,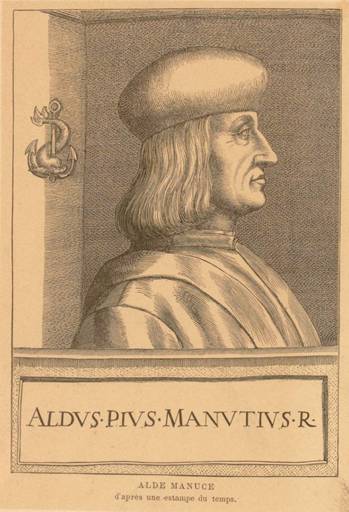
VENTATA DI �UMANESIMO
DALL� ALTO �MEDIOEVO IN IRLANDA
AL RINASCIMENTO �A VENEZIA
L�ELLENISMO
DALL� IRLANDA
GIUNGE
A VENEZIA
PER
MERITO DI ALDO MANUZIO
Michele E.
Puglia
PARTE
PRIMA
AI LETTORI
(con
raccomandazione ai giovani studenti di leggere
questi articoli, formativi per la
loro cultura!).
Se cerate �in questo articolo,
troverete una parte della mia
anima;
ora che sono nella fase conclusiva
della vita,
esso costituisce il termine
�degl articoli o se volete, saggi, di carattere
umanistico
scritti per la curiosit� e
l�interesse
che, per questo periodo storico,
mi erano stati� inculcati�
�al primo liceo, da un giovane e strano
insegnante di lettere, passato come
una meteora
e avuto solo in quell�anno; �scomparso
�con il suo nome dalla mia memoria, come lo era
stato dalla scuola;
lo ricordo solo nell�aspetto fisico,
prestante e
nella sua brillante vivacit�
intellettuale, che mi
aveva lasciato il segno per gli
anni futuri.
Onore quindi agli insegnanti che
lasciano il segno!
*� *� *
Nell�art,
Carlo V tra Rinascimento Riforma e
Controriforma,
nella
P. I. Sez.I, �in cui si parla de �L�umanesimo
sconosciuto�,
abbiamo
fatto risalire gli studi pre-umanistici a Dante,
Petrarca e Boccaccio
e
al Dolce Stil Novo, e la diffusione
della lingua greca
�(�Sono
greche le parole dei nostri pensieri�) agli
studiosi� che, verso la met� del �400� erano giunti in
Italia� �
dalla
Grecia (alcuni di quelli qu� menzionati,
sono
indicati nell�art. precedente tra i pre-umaanisti);
�
�con il presente articolo, l�elenco di costoro
pu� ritenersi completo
e
gli studi umanistici vanno ancor pi� retrocessi
e
fatti iniziare �al VI secolo, come
riferiamo,
al
periodo della �diffusione
ad
operaa dei monaci irlandesi.
*� *� *
SOMMARIO: DECADENZA
DELLA LETTERATURA GRECA CON IL TRASFERIMENTO IN ORIENTE DELL�IMPERO ROMANO;
L�ELLENISMO DA UNA ESTREMITA� DELL�OCCIDENTE�
SI TRASFERISCE NALL�ALTRA ESTREMITRA� IN IRLANDA; PRIMORDI DELLA LINGUA
GRECA INTRODOTTA IN IRLANDA (In Nota: LA BARBARIE DEL REGIME IN IRAN E LA
DEBOLEZZA DELL�U.E. INCOMPIUTA); IL CRISTIANESIMO IN IRLANDA E LE SCUOLE
IRLANDESI; COLOMBANO ESPULSO DALLA GALLIA DA BRUNECHILDE PER L�AFFRONTO SUBITO;
GLI ANTICHI MONACI IRLANDESI INDIPENENTI DALLA CHIESA DI ROMA; LA SCUOLA
PALATINA ALLA CORTE DI CARLOMAGNO E I BATTIBECCHI NELLA SCUOLA; GIOVANNI SCOTO
ERIGENA CHIUDE IL CICLO DELLE SCUOLE IRLANDESI CHE SI CONFONDONO CON LE LATINE;
�I DUE MOTORI DELLA CULTURA IN OCCIDENTE:
LA RINASCENZA E LA STAMPA; LA SCUOLA DI EMANUELE CRISOLORA E I SUOI ALLIEVI A
FIRENZE;� L�ELLENISMO NELLE �PICCOLE CORTI DI FERRARA MANTOVA E URBINO ELEZIONE
DEL PAPA NICOLA V; A CHE �PUNTO ERANO GLI
STUDI DEL GRECO QUANDO ALDO� INIZIAVA �LA SUA�
ATTIVITA.
�
DECADENZA
DELLA LETTERATURA
GRECA
CON IL TRASFERIMENTO
DELL�IMPERO ROMANO
IN ORIENTE
|
C |
on
la caduta dell�impero romano, quando Costantino nel 395 si era trasferito a
Bisanzio, la lingua latina in Occidente scompariva completamente, sebbene� alcuni vescovi o abati nel VI secolo, avessero
fondato qualche scuola per rimpiazzare quelle dei romani, dalle quali
l�educazione letteraria era esclusa.
L�uso
della lingua latina era andata sempre pi� alterandosi e la cultura delle
lettere latine antiche era completamente scomparsa e quella greca, nel mondo
ecclesiastico era divenuta oggetto di avversione a causa delle frequenti eresie
che sorgevano in Oriente.
Bisanzio
era divenuta sede delle questioni religiose che avevano invaso il campo
intellettuale, durante diversi secoli. La letteratura greca antica aveva
trovato pochi cultori e nessuna influenza, in quanto i grandi modelli non
avevano trovato nessun ammiratore tra i personaggi di rilievo; e furono gli
stessi greci a distruggere i loro tesori letterari, nell�interesse della
religione.
Alcionio,
sulla testimonianza di Demetrio Calcondila, segnalava la disastrosa influenza
degli ecclesiastici di Bisanzio, sulla distruzione, in parte o nella totalit�,
delle opere di Menandro, Difilo, Apollodoro, Filemone, Alessio, Saffo, Corinna,
Anacreonte, Minermo. Bione, Alcmane e Alceo.
Nello
spazio di pi� dieci secoli, nei quali si svolgeva l�impero d�Oriente, non si
vedeva un solo autore greco che potesse essere comparato alle glorie
letterarie� dell�antichit�. Si incontravano
dei lessicografi, commentatori, geografi, medici, studiosi di filosofia, poeti
e romanzieri che superavano appena il livello generale; la sola storia aveva
qualche scrittore di talento.
La
decadenza letteraria della Grecia, coincideva con la sua decadenza politica;
nel settimo secolo, improvvisa, una nuova potenza, come una valanga, invadeva
il vecchio mondo: erano gli arabi; in poco tempo essi spogliavano la Grecia dei
suoi possedimenti in Asia, Africa; Alessandria, questo grande centro del sapere
greco, cadeva in loro potere (640); ad essi si attribuiva la distruzione della
celebre biblioteca fondata dai Tolomei; ma ci� era inesatto in quanto una parte
era scomparsa quando la citt� era stata presa da Cesare (47 a. C.) ed era
rimasto il Serapium, distrutto dal
patriarca di Alessandria, Teofilo (390), sotto l�imperatore Teodosio, che con
il suo selvaggio fanatismo cristiano, aveva voluto distruggere col fuoco, ci�
che riteneva il frutto della idolatria
alessandrina.
Gli
arabi, nel periodo delle loro conquiste, infiammati dal loro fanatismo
religioso che ammetteva il solo libro sacro,�
il Corano, come unico testo di conoscenza, avevano mostrato lo scarso
interesse per la letteratura cristiana, ma si erano mostrati sensibili per le
scienze greche e con Harun al Rashid erano iniziate le traduzioni della
letteratura greca, filosofia, medicina e scienze; per cui gli arabi con Harun
al Rashid, avevano avuto il loro periodo d�oro (v. Art. La scienza araba ecc.) le cui traduzioni che furono trovate a
Toledo riconquistata (1085) dai cristiani.
Pietro
il Venerabile, abate di Cluny (sappiamo che egli stesso era stato in Spagna
dove aveva iniziato a far tradurre l�Alcorano),
aveva mandato suoi monaci a Toledo, affidando l�incarico della traduzione a un
toledano, Pietro di Toledo, che conosceva l�arabo e a un monaco, Pietro di
Poitiers, che conosceva il latino, per
avere una traduzione esatta e piacevole dell�Alcorano, e a due astronomi
incontrati in Spagna, uno inglese, Roberto di Ketton, arcidiacono di Pamplona e
l�altro, il dalmata� Ermanno.
Costoro
a Toledo si trovarono di fronte alla ricchezza del sapere umano, tradotto dagli
arabi; e grazie a questa ricchezza il medioevo pot� conoscere direttamente, i
testi di Aristotele e dei medici greci, di geografia, di scienze, che furono
tradotti e finirono nelle univarsit� per essere studiati (v. Articoli cit. La scienz araba ecc. P. I e II), cos�
formando la cultura dell�Occidente.
Dall�altro canto, l�invasione musulmana, della
Grecia, aveva determinato la soppressione della lingua greca che fu limitata
alla sola Grecia propriamente detta.
La successiva conquista dei francesi nel 1204
durata fino al 1261, aveva fatto predominare la lingua francese e la vicinanza
dei costumi e del carattere tra i due popoli, aveva prodotto un tale
avvicinamento, che il papa Onorio riteneva la Morea una nuova Francia, e lo
storico guerriero Ramon Muntaner, richiamando i numerosi matrimoni tra i
principi e cavalieri greci e francesi, riteneva che �la pi� nobile cavalleria fosse quella della Morea dove si parlava il
francese meglio che a Parigi�.
A partire dal XIVmo secolo una nuova dominazione
si abbatteva sulla Grecia; i turchi ottomani, vincitori degli arabi in Asia,
avanzavano verso l�Europa e rilevavano i lembi del patrimonio greco: tutto ci�
che era stato dominio della cultura araba, passava alle orde asiatiche; la
lingua greca era minacciata nella sua stessa esistenza. Il cristianesimo,
funesto per le opere profane dell�antichit�, aveva dato alla letteratura greca
un nuovo periodo di gloria,� grazie agli
scritti del Padri della Chiesa, salvando la lingua greca, gi� alterata, da un
completo annientamento .
Il mondo aveva conosciuto i Vangeli, attraverso
la lingua greca; mentre si manteneva come lingua liturgica nella Chiesa
orientale, essa era trasferita in Occidente nel momento in cui tutta la Grecia
cadeva sotto il giogo musulmano.
�
L�ELLENISMO
DA UNA ESTREMITA�
DELL��OCCIDENTE
SI RIFUGIA NELL�ALTRA
ESTREMITA� IN IRLANDA
|
L |
�ellenismo, bandito dagli estremi confini dell�Occidente,
andava a rifugiarsi nell�isola d�Irlanda che era sfuggita alla conquista romana,
dove lo stato delle lettere era fiorente in quanto, il misticismo, che
costituiva il fondo del carattere irlandese, li rendeva inclini alle
meditazioni filosofiche, ci� che spiega l�ardore mostrato per le dottrine
platoniche.�
Lo studio della lingua greca infatti, aveva
formato una delle basi del loro insegnamento, e, queste tendenze, poco
compatibili con la severa ortodossia del continente, erano favorite dalla
posizione geografica dell�Irlanda, che non solo l�aveva preservata dalle
invasioni barbariche, ma l�aveva resa anche meno sottomessa alla vigilanza
della Corte di Roma.
Con la predilezione per la letteratura pagana,
il clero irlandese era animato da un grande zelo apostolico ed era stato dai
suoi ranghi che erano stati reclutati i pi� ardenti propagatori della fede
cristiana in Occidente.
Negli ultimi anni del VI secolo, un monaco
austero, Colombano, accompagnato da dodici religiosi si era recato in Gallia,
nel regno di Borgogna, dove, duraante il regno di� Gontrano (v. Art. Brunechilde e Frdegonda ecc.),
aveva fondato diversi monasteri, dei quali quello di Luxeuil era divenuto il
pi� celebre.
Egli poi era andato a predicare ai bordi del
Reno, in Elvezia e in Lombardia; considerato�
poeta latino di vaglia, per la sua profonda educazione letteraria, sui
grandi modelli dell�antichit�, soprattutto greca, i cui ricordi si riscontravano
nei suoi scritti, e la Chiesa, per i suoi meriti, lo aveva inserito nel numero
dei suoi santi.
Tutti i monaci che partecipavano alla
fondazione dell�abbazia di Luxeuil, dovevano conoscere il greco; questa scienza
si affacciava gradualmente nella Gallia, al contatto del purismo romano, ma
ancora nel dodicesimo secolo, le vestigia di alcuni termini greci, si ritrovavano
nei manoscritti di questa abbazia, come testimoniava un prezioso evangelario di quest�epoca, opera del
suo abate, Gerardo.
Uno dei compagni di Colombano, san Gallo, aveva
fondato un�altra abbazia, divenuta celebre sotto il suo nome, dove la lingua
greca era ugualmente coltivata tra le mura del chiostro.
Le lettere greche erano penetrate dall�Irlanda
nella vicina grande isola Anglo-Sassone, dove il suo successo era aumentato
quando vi era giunto Teodoro, greco asiatico, nativo di Tarso, inviato dal papa
nel 668 ad Atene, in qualit� di vescovo di Canterbury.
Per mezzo delle scuole episcopali di questa
contrada (le pi� celebri erano quelle di Canterbury e di York), scuole
dove si insegnavano le scienze sacre e profane e dove gli allievi, secondo la
testimonianza di Beda (Historia
Ecclesiastica), parlavano il greco, come loro lingua madre; la scuola di
York possedeva una biblioteca ricca di testi e manostritti di opere
dell�antichit�.
Alcuino, al quale la biblioteca era stata
affidata nel 766, in un poema latino (*), ne aveva enumerato i tesori letterari
che vi si trovavano:- �Tutto ci� che la
brillante Grecia ha trasmesso ai Latini, tutte le piogge divine che placano la
sete del popolo ebraico, tutte queste luci risplendenti con le quali l�Africa
ha ricoperto le sue opere e i trattati di Girolamo e Agostino ...�� (**).
Si pu� notare che Platone non figura perch� le
tendenze del clero anglo-sassone differivano da quelle del clero irlandese
Spinto dalla nobile ambizione di espandere le
luci del suo impero, � dall�Irlanda e dall�Inghilterra che Carlomagno aveva
preso insegnanti per la sua Scuola
palatina, destinata a divenire vivaio di uomini istruiti nelle scienze e
nelle lettere. Tra questi insegnanti i pi� illustri erano,
l��anglo-saassoneAlcuino e il monaco irlandese Clemente, ambedue familiarizzati
con la letteratura antica; essi rappresentavano alla Corte imperiale due
dottrine diametralmente opposte, Alcuino, ortodosso, autoritario, si appoggiava
ad Aristotele; Clemente d�Irlanda, suo successore, alquanto libero pensatore,
come i suoi compatrioti del tempo, apparteneva alla scuola neoplatonica. Questo
antagonismo andava tutto a vantaggio dei loro allievi che acquisivano una
conoscenza pi� estesa dei grandi studiosi della Grecia.
Gli insegnanti irlandesi, godevano� di una maggiore autorit�, di quella dei loro
competitori presso Carlomagno e suoi successori. Pi� istruiti nella lingua
greca dei loro vicini insulari, � ad essi che occorre esser grati per la
cultura ellenica diffusa in Francia. Si � detto che Carlomagno parlasse
correntemente il greco, ma ci� appare dubbio; a dire di Alcuino, Eginardo era
molto istruito sulla lingua di Omero.
Il maggiore ellenista di quest�epoca, era Scoto
Erigena,� uomo dalla sorprendente
genialit� che aveva cercato di conciliare la teologia cristiana con il
neoplatonismo d�Alessandria. Era venuto dall�Irlanda per presiedere la
direzi0ne della Scuola palatina di
Carlo il Calvo;� l�arditezza delle sue
dottrine filosofiche, fin� per sollevare contro di lui la Chiesa latina; egli
dovette ritirarsi e l�ellenismo irlandese non trov� pi� favore a Corte.
Il
consolidamento e l�estensione dell�autorit� pontificia causarono l�abbassamento
degli studi puramente letterari e nel IX secolo la separazione delle Chiese di
Oriente e Occidente ebbe una influenza decisiva sui destini degli studi greci.
A partire da quest�epoca, durante diversi secoli, malgrado i progressi
pressoch� costanti della civilizzazione, era raro incontrare in Europa qualcuno
che fosse un poco al corrente della letteratura greca o che avesse una flebile
nozione di questa lingua.
Ma. sebbene
lo studio del greco fosse caduto nell�oblio, la sua influenza� non sussisteva di meno; sembra comunque che,
ai tempi in cui essa era pi� trscurata, fosse glorificata da parte di coloro
che la ignoravano, ma davano l�impressione di conoscerla. Si trovano, in alcuni
testi di Cicerone ed altri, delle parole greche tratte in lettere latine e la
parola �τέλος� (fine), si trova
spesso riportata alla fine dei manoscritti latini.
L�ellenismo era scomparso in Irlanda come nel
resto dell�Occidente; tuttavia Aristotele regnava maestro, ma le sue opere
erano conosciute nelle traduzioni latine che erano state fatte, in parte
dall�originale, da Boezio e pi� particolarmente dalle versioni arabe tradotte
dalle versioni siriache. sotto il regno di Aroun al Rashid, contemporaneo ed
emulo di Carlomagno.
Tutto il sapere passava per le mani esclusive
del clero, che proscriveva segnatamente gli autori profani, se non erano
eliminati; fortunatamente, un�altra porzione di clero, attenuava, senza porre
dei dubbi, questo assurdo ostracismo. I monaci benedettini, conformemente alle
prescrizioni del loro fondatore, nel copiare i manoscritti, come vedremo pi�
avanti, poich� san Bnenedetto non si era pronunziato sulla loro esclusione, gli
amanuensi riproducevano indifferentemente gli autori profani� e gli autori sacri e nei conventi si
formarono cos� collezioni di autori greci e latini che saranno ripescati al
momento opportuno.
*) Poema
de pontificibus et sanctis ecclesiae eboracensis (Poema dei pontefici e
santi della chiesa di York).
**) Attanasio, i libri di Orosio, gli� insegnamenti di Greegorio Magno, di Leone, la
parola eclatante di Basilio e Fulgenzio, Cassiodoro, Giovnni Crisostomo,� ci�e dottrine di Anselmo, il maestro Beda, Vittorino
e Boezio, gli antichi storici Pompeo e Plinio, il penetrante Aristotele e
Cicerone, il grande oratore; infine i canti di Sedulio, Juvenco. Alcme,
Clemente, Prospero, Paolino, Aratore de Fortunato, Lattanzio, Virgilio, Stazio,
Lucano, Probo, Foca, Donato, Prisciano, Servio, Euticio, Comminiano.
PRIMORDI �
DELLA LINGUA
GRECA
INTRODOTTA
IN IRLANDA�
|
D |
opo la definitiva
separazione dell�impero d�Occidente (395), Costantinopoli divenne la sede delle
questioni religiose e delle eresie, che invasero il campo intellettuale �durante parecchi secoli ( v. in Art. I mille anni dell�impero bizantino e in
Schede S. Filioque ecc.).
La
letteratura greca antica trov�� pochi
ammiratori e non ebbe pi� influenza perch� i suoi grandi modelli non ispiravano
pi� i grandi studiosi. Per di pi� gli stessi greci con i divieti religiosi, avevano
distrutto i loro tesori letterari. Come abbiamo visto, i preti di Costantinopoli,
avevano distrutto la totalit� delle opere di Menandro, Difilo, Apollodoro, ecc. .��� �
Nello
spazio di dieci secoli di esistenza dell�impero d�Oriente, non si era visto un
solo scrittore che avesse potuto essere paragonato alle glorie letterarie
dell�antichit�; non vi erano che lessicografi, commentatori, geografi, medici,
filosofi, compilatiori, poeti e romanzieri, che sorpassavano di poco il livello
generale e per la storia si trovava solo qualche scrittore di talento. La
decadenza letteraria della Grecia, coincideva con la diminuzione successiva
della sua importanza politica (Amboise-Firmine Didot, Alde Manuce et l�Hellenisme � Venise, Paris 1875). �
Nel
settimo secolo sorgeva all�improvviso, come una valanga, una nuova potenza che
invadeva il vecchio mondo: gli arabi che in poco tempo� spogliavano i greci dei loro possedimenti in
Asia e Africa.
Alessandria
(prosegue Firmin-Didot), questa gran fucina del sapere greco, cadeva in loro
potere (640); a loro si attribuiva la distruzione della celebre biblioteca
fondata dai Tolomei, ma ci� � inesatto in quanto una parte era scomparsa a
causa delle fiamme della citt� quando Cesare le aveva dato fuoco; in questa
circostanza, �si era salvato� il Serapeo,
distrutto sotto l�imperatore Teodosio (390) con il tempio di Serapide, sotto �l�istigazione del patriarca di Alessandria,
Teofilo, per il suo� proselitismo selvaggio
con cui volle� imporre agli alessandrini,
con il ferro e il fuoco, il culto cristiuano. �
Questo
stesso fanatismo religioso sar� ereditato dagli arabi, che non ammettevano che
un solo libro, il Corano, mostrandosi poco favorevoli alla letteratura greca; �mentre si mostrarono favorevoli alle scienze,
di cui, con le traduzioni, trasmisero tutta la loro ricchezza (v. in Art. La sciena araba alle origini della cultura
Occidentale).
L�illuminato
califfo Harun al Rashid (cit. Art.), fece tradurre opere letterarie greche e
l�impulso che aveva dato, permise agli arabi di essere i primi nelle scienze.
Il
califfo al-Mutawakkil (VIII sec.) a Bagdad aveva dato una stretta alla
ortodossia dando ordine che fossero dati alle fiamme tutti i libri filosofici
di Avicenna e dei Fatelli della� sincerit�. Nel 1194 l�emiro Abu Yusuf
Yaqub al-Mansur, a Siviglia, aveva ordinato che fossero bruciati tutti i libri
di Averro�, ad� eccezione di alcuni di
scienze naturali; proibiva ai sudditi di riprendere gli studi di filosofia e li
esortava a gettare nel fuoco qualsiasi libro di filosofia.
La
ortodossia, posta con �la fede� a
fondamento della sua dottrina, Abu Hamid al-Ghazali (1058-1111), fin� per
prendere il sopravvento sulla filosofia e gli effetti che ne derivarono furono
ben diversi dai principi enunciati, perch� la sue dottrine, se pur moderate,
erano state male intese (ed esasperate); con la conseguenza che avevano portato
alla� distruzione della tolleranza e
della libert�, di cui fino a quel momento aveva goduto l�intero Islam.
L�Islam aveva
avuto i suoi Leonardo, l�Umanesimo e il Rinascimento, i Bacone (Ruggero e
Francesco), i Cartesio, andando oltre con i Voltaire. i Diderot e
l�Illuminismo, i precursori di Rousseau e Nietzsche, con� menti eclettiche che primeggiavano
contemporaneamente nelle scienze, nella medicina, nella matematica,
nell�astronomia, nella filosofia e nella poesia, quando l�Europa era ancora avvolta
nel buio della barbarie.
Dopo aver
raggiunto questo alto grado di civilt�, l�Islam era caduta nell�intolleranza,
anticipando� nei metodi, ci� che
avrebbero fatto i cristiani� in Europa
alcuni secoli dopo, facendo ricorso all�Inquisizione.
Ora
l�Islam � divenuto oscurantismo ed � causa di continua lotta e fermenti contro
la pace nel mondo! (**)
Tornando
al nostro argomento, la successiva invasione musulmana dei paesi greci port�
alla soppressione della lingua ellenica che si mantenne solo nella Grecia
propriamente detta, dove, dopo la conquista francese (1204-1264), particolarmente
in Morea (era il Peloponneso, cos� detto perch� aveva la forma della foglia del
gelso), divenne predominante la lingua francese per i matrimoni incrociati che
vi ebbero luogo.
A
partire dal quattordicesimo secolo (prosegue Firmin-Didot) i turchi ottomani,
vincitori degli arabi in Asia, avanzarono �verso l�Europa; la lingua greca era minacciata
nella sua stessa esistenza.� �����
Il
cristianesimo, funesto per le opere profane, aveva dato alla letteratura greca
un periodo di gloria, con gli scritti dei Padri
della Chiesa che salveranno la lingua greca, gi� fortemente alterata, da un
completo annientamento.
Il
mondo aveva conosciuto i Vangeli, nella Chiesa orientale, attraverso la lingua
greca; trasportata in Occidente nel momento in cui tutta la Grecia era caduta
sotto il giogo dei musulmani e l�ellenismo, bandito dal continente occidentale,
and� a rifugiarsi all�altro estremo dell�Occidente, nell�Irlanda, scappata alla
conquista romana.
Lo
stato delle lettere era fiorente dopo secoli, grazie allo zelo dei Druidi che
avevano importato i loro lumi dai Galli. Convertiti al cristianesimo, gli
irlndesi si �legarono al proselitismo sacro di cui parla Beda
nella sua Storia Ecclesiastica.
�Il misticismo che costituiva il fondo del
carattere irlandese, li rese inclini alla meditazione filosofica, ci� che
spiega il loro ardore per le dottrine platoniche: lo studio della lingua greca,
formava quindi� una delle basi del loro
insegnamento.
Queste
tendenze, poco compatibili con la severa ortodossia del continente, erano� favorite dalla posizione geografica
dell�Irlanda, che l�aveva preservata dalle invasioni barbariche e la rendeva
sottomessa alla vigilanza della Corte di Roma.
Professsando
la loro predilezione per la letteratura pagana, il clero irlandese era animato
da un grande zelo apostolico e tra suoi ranghi si reclutavano i pi� ardenti
propagatori della fede cristiana in Occidente.
Negli
ultimi anni del VI secolo, un monaco austero, Colombano, accompagnato da dodici
religiosi, si era recato dall�Irlanda in Francia, e con il permesso del re borghignone
Gontrano, innalzava diversi monasteri, tra i quali l�abbazia di Luxeuil, che in
seguito divenne famosa, per poi portare il vangelo ai bordi del Reno, in
Svizzera e in Lombardia (v. cit. Art. Brunechilde e Fredegonda, ecc.).
La
Chiesa, riconoscente per il suo apostolato, lo poneva nel numero dei suoi
santi; la letteratura si onorava di possedere in lui il pi� grande poeta latino
�del suo tempo e questa gloria, Colombano,
la doveva alla sua profonda educazione letteraria, soprattutto greca, sui
modelli dell�antichit�, i cui ricordi si ritrovano sparsi sotto la sua penna.
Tutti
i monaci che parteciparono alla fondazione dell�abbazia di Luxeuil, dovevano
conoscere il� greco; questa scienza si
affacciava gradualmente in Francia a contatto con il purismo romano, ma ancora
nell�XI sec. se ne trovava vestigia di qualche motto greco nei manoscritti,
redatti in questa abbazia. come testimoniato da un prezioso evangelario di
questa stessa epoca, opera del suo abate Gerardo.
Uno
dei confratelli di Colombano, canonizzato sotto il nome di San Gallo, aveva
fondato un�altra abbazia, ugualmente celebre che portava il suo nome, dove era
coltivata la lingua greca, ma i suoi echi erano rimasti entro le mura del
convento.
Le
lettere greche erano penetrate in Irlanda, provenendo dalla vicina grande isola
degli anglo-sassoni e la loro espansione ebbe luogo� dopo la venuta di Teodoro, greco asiatico,
nativo di Tarso, educato ad Atene e inviato (668), dal papa Vitaliano, in
qualit� di arcivescovo di Canterbury.
In
queste scuole episcopali (Canterbury e York) si insegnavano le scienze sacre e
profane e gli allievi (secondo la testimonianza di Beda), parlavano facilmente
il greco come lingua materna; la scuola di York, possedeva una biblioteca ricca
di manoscritti di opere dell�antichit�.
Alcuino
(735-804) al quale (dopo il 766) era stata affidata la direzione,� enumerava (nel Poema de pontificibus et sanctis de Ecclesiae Eboracensis), i
tesori letterari che vi si trovavano (*). Tra di essi non vi figurava Platone,
in quanto le tendenze del clero anglo-sassone erano differenti da quelle irlandesi.
�
Spinto
dalla nobile ambizione di espandere i lumi del sapere nel suo impero, � dall�Irlanda
e Gran Bretagna che Carlomagno importava gli insegnanti per la sua Scuola palatina, destinata a divenire un
vivaio di uomini istruiti nelle scienze e nelle lettere, primo fra tutti
Alcuino (v. in Art. Carlomagno e l�idea
dell�Europa).
Con
Alcuino, presso la Scuola palatina
primeggiava anche il monaco Clemente; ambedue familiarizzati nelle lettere
greche, rappresentavano nella Corte imperiale due dottrine diametralmente
opposte. Alcuino, ortodosso autoritario si appoggiava ad Aristotele; Clemente
d�Irlanda, suo successore, alquanto libero pensatore, apparteneva alla scuola
neoplatonica. Questo antagonismo andava a vantaggio degli allievi che acquistavano
una conoscenza pi� estesa dei grandi scrittori della Grecia.
I
professori irlandesi godevano di una autorit� maggiore dei loro competitori
presso Carlomagno e presso i suoi successori: a dire di Alcuino, Eginardo era
molto istruito sui canti di Omero.
Il
maggior ellenista di quest�epoca era Giovanni Scoto Eriugena (o Erigene), uomo
di sorprendente genialit�, che cercava di conciliare la teologia cristiana con
il neoplatonismo di Alessandria; giunse dall�Irlanda per prendere la direzione
della Scuola palatina, alla Corte di
Carlo il Calvo. L�arditezza delle sue dottrine filosofiche fin� per sollevare
contro di lui la Chiesa latina (i suoi libri saranno messi nell�Index Librorum Prohibitorum); egli
dovette ritirarsi e l�ellenismo irlandese non trov� pi� aria favorevole a
Corte.
Il
consolidamento e l�estensione dell�autorit� pontificia portarono all�abbassamento
graduale degli studi puramente letterari e nel IX secolo, la sepaarazione della
Chiesa d�Oriente� e d�Occidente ebbe un�influenza
decisiva sul destino degli studi greci.
A
partire da quest�epoca, durante diversi secoli, malgrado il progresso quasi
costante della civilizzazzione, era raro trovare in Europa, qualcuno che fosse
al corrente della �
letteratura
greca o fosse poco al corrente di una qualsiasi nozione di questa lingua.
Ma
bench� lo studio del greco fosse caduto nell�oblio, la sua influenza non
sussisteva meno; sembra che si facesse ugualmente onore nel tempo in cui era
ignorata. Firmin-Didot, afferma che in un manoscritto latino di Cicerone ed
altri, aveva trovato dei motti greci, scritti in lettere latine, di cui lo
storico riportava degli esempi.
L�Ellenismo
scomparve� in Irlanda come nel resto
dell�Occidente. Tuttavia Aristotele vi regnava maestro, ma le sue opere non
erano conosciute che nelle traduzioni latine fatte in parte, sull�originale da
Boezio e pi� particolarmente, dalle versioni arabe eseguite su delle traduzioni
siriache, sotto il regno e per ordine di Harun al Raschid, contemporaneo di
Carlomagno (v. in Art. La scienza araba alle origini della civilt� europea).
Tutto
il sapere passava sotto l�esclusivo dominio del clero che aveva segnatamente
proscritto le opere di autori profani, se non erano state distrutte; ma per
fortuna, una parte del clero,� aveva
attenuato questo assurdo ostracismo.
I
monaci benedettini, conformemente alle prescrizioni del loro fondatore, impiegavano
il loro tempo libero a copiare i manoscritti; e poich� san Benedetto, vissuto
nel VI secolo, epoca in cui la cultura dell�antichit� era ancora in favore, non
si era pronunciato sulla loro esclusione, i suoi discepoli riproducevano
indifferentemente gli autori pagani e quelli sacri.
Si
formavano cos� nei conventi delle collezioni preziose di autori greci e latini,
grazie alle quali si erano riservati degli strumenti di lavoro per quando
suoner� l�ora del risveglio.�� �
*)
Alcuino, nel suo �Poema de pontificibus
et sanctis Ecclesiae Eboracensis� cos� si esprimeva: �Tutto ci� che la brillante Grecia ha trasmesso ai latini, tutte le
piogge divine che placano la sete del popolo ebreo, tutte queste luci
splendenti che hanno ricoperto l�Africa, i trattati di Girolamo, Agostino,
Attanasio. il libro di Orosio, le parole eclatanti di Basilio e di Fulgenzio,
Cassiodoro, Giovanni Crisostomo, le dottrine di Altelmo, del maestro Beda, di
Vittorino e di Boezio, gli antichi storici Pompeo e Plinio, il penetrante Aristotele
e Cicerone, il grande oratrore; infine i canti di Sedulio, Juvenco, Alcime,
Clemente, Prospero, Paolino, Aratore, Fortunato, Lattanzio, Virgilio, Stazio,
Lucano, Probo, Foca, Donat, Prisciano, Servio, Euticio, Comminiano�.
LA
BARBARIE DEL REGIME� IN IRAN E LA
DEBOLEZZA DELL�U.E INCOMPIUTA
**)
Ai giorni nostri la barbarie religiosa derivante da puro e ingiustificato fanatismo,
si sta rinnovando in Iran, in maggioranza sciita, paese di antica civilt�,
caduto in un rigoroso, antistorico e brutale fanatismo religioso, che per opera
dell� ayatollah Khomeyni, da quando �
al potere, sta comducendo una brutale
falcidia di giovani, ragazze e ragazzi, che chiedono solo la libert� di vivere
la loro giovinezza.
In
particolare, le ragazze chiedono di liberarsi dal velo, indice dell�oppressione
maschilista e per protesta tagliano i loro folti e bei capelli, conducendo a
questo modo, la loro rivoluzione,� combattuta
con metodi medievali: frustate (74 frustate alla curda Roya Heshmati per
essersi fatta fotografare senza hijab!) e giornaliere impiccagioni. Khomeyni si
serve della c.d. polizia morale, formata
da assassini e stupratori che, senza un minimo di rispetto per la persona e
vita umana, stuprano le giovani ragazze e le feriscono mirando principalmente agli
occhi.
Tutto
ci�, nel silenzio delle organizzazioni intenazionali come, l� ONU, dove, ironia
della sorte, la Presidenza per i Diritti Umani � stata assegnata �(2023) a un iraniano!
Non
solo. ma l�Iran sciita, per mezzo degli Huthi che si sono impadroniti dello
Yemen, sta conducendo una subdola lotta contro l�Occidente con la pirateria del
Mar Rosso, che sta sconbussolando il sistema dei trasporti, con le navi container costrette a compiere il
periplo dell�Africa, per recarsi direttamente ai porti del Nord, con grave �danno per l�economia dell�intera Europa e in
particolare dell�Italia.
Purtroppo
la U.E. che ci rappresenta, � debole e in�
settant�anni dalla sua costituzione � ancora incompiuta e non � riuscita
a darsi una autonomia di governo, mancando delle �istituzioni che la renderebbero autonoma, vale
a dire, un Governo con i suoi ministri e unaa propria politica estera, un
Parlamento che lo elegge e un esercito per la propria difesa.
Mal
governata da cinque anni da una Presidente del tutto inadeguata, riconfermata
per altri cinque anni, � facile prevedere che neanche una di queste istituzioni
sar� realizzata.
Per
di pi�, al suo interno � bersagliata da ciascuno dei ventisette paesi che la
compongono, tra i quali manca una uniformit� di vedute e una coesione e ognuno
difende i propri interessi nazionali a scapito della sua indipendenza.
Certamente non erano questi i presupposti su cui l�U. E. era stata fondata che
erano di carattere federale e non confederato, come invece ora vogliono i c.d.
sovranisti.
Con
questo esasperato nazionalismo, che
tale � il sovranismo, l�U.E. � condizionata
dallo zoccolo duro dei Paesi dell�Est, capeggiati dall�Ungheria di Victor Orban,
il quale, mentre da una parte rastrella tutto il danaro che pu� per gli aiuti da
essa erogati, dall�altra si oppone a tutte le decisioni poste in votazione
(approfittando del diritto di veto che, anacronisticamente � ancora
riconosciuto ai Paesi partecipanti); essendo la sua politica chiaramente antieuropea,
dovrebbe essere estromesso �dall�Unione �senza ulteriori esitazioni.
Oltretutto
sono in attesa di entrare altri dieci
paesi dell�area balcanica, i quali, dopo la sanguinosa guerra degli anni
novanta, sono ancora in continuo fermento per gli stessi motivi nazionalisti etnico-religiosi, che l�avevano
determinata (per non parlare dell�Albania nelle mani della criminalit�):
purtroppo le religioni invece di portar pace e amore, portano odio eccidi e
guerre sanguinose. ��
Poich�
questi Paesi, non sono riusciti a raggiungere un equilibrio di convivenza, nelle
attuali condizioni in cui si trova la U.E., il loro ingresso costituirebbe un grave
iattura per l�unione.�
E,
mentre incombono i pericoli dell�Islam, dell�imperialismo russo e l�invadenza
mondiale del narco-traffico dell�America Latina, � in preparazione un nuovo
Ordine Mondiale, post-occidentale che l�Europa dovr� prepararsi ad affrontare, se
non vorr� soccombere definitivamente; ed essendo sempre vissuta all�ombra degli
USA. non sappiamo se sar� in grado di farlo!
�
IL CRISTIANESIMO
IN IRLANDA E LE
SCUOLE
IRLANDESI
|
I |
l
cristianesimo era stato introdotto in Irlanda all�inizio del V secolo da san
Patrizio (385-461), l�apostolo d�Irlanda,
il quale, prima di Colombano (540-615), aveva incominciato a distruggere il
culto pagano dei druidi (v. cit. Art.
Brunechilde e Fredegomda ecc.). L�opera
di conversione aveva trovato terreno favorevole ed era avanzato rapidamente e i
conventi erano stati innalzati prima di san Benedetto (480-547); poi il
cristianesimo era avanzato in Scozia, sua patria d�origine.
�Santa Brigida (1303-1373), dal suo canto,
innalzer� monasteri femminili cominciando dalla badia di Kildora e cos�
l�Irlanda fu denominata l�isola dei santi.
Teodoro, arcivescovo di Canterbury, spedito in Inghilterra� con l�abate Adriano, oriundo dell�Africa che
lo accompagnava, contribu� alla espansione del cristianesimo anche in Gran
Bretagna dove la scuola di Canterbury divenne la prima in Europa, diffondendo
la lingua latina e greca, parlate unitamente al volgare materno.
In
questo periodo, anche in Gran Bretagna emergeva la figura di Beda il Venerabile
(673-735) che con le sue cognizioni enciclopediche (nei suoi scritti si trovano
citazioni di Plinio il Giovane, Lucrezio, Orazio, Ovidio e altri autori
classici), nel monastero di san Pietro e Paolo a Wearmouth e a Jarrow nel
Northamberland, favoriva la gloria letteraria dei suoi contemporanei, quali il
monaco Adhelm (Adelmo, ne �In nome della
Rosa�), discepolo di Adriano e superiore a Beda come poeta e giureconsulto.
Mentre a York, troviamo Alcuino (detto di York), dov�era nato, (735 c.ca-804), che
fu capo vescovile di quella citt� e il vero�
restauratore degli studi nell�impero di Carlomagno (v. in Art. �Carlomagno e l�Idea dell�Europa�) .
La storia delle scuole irlandesi (scriveva
Firmin-Didot) � purtroppo oscura e ci� che si conosce crea maggior meraviglia: nel
VI secolo, come abbiamo visto, vi era una regione del mondo antico, dove la tradizione
delle lettere latine e greche si era conservata e dove una moltitudine di
giovani cristiani era circondata da maestri che insegnavano a comprendere Omero
e Virgilio, e questa regione era l�Irlanda. �
Non si conosce, nelle origini della scienza
moderna (scrive B. Haur�au, Ecole Irlandaise. Paris 1861), un avvenimento di
simile portata, ma cerchiamo di sapere chi furono i precettori di questi
irlandesi.
Giovenale attesta� che i Galli trasmisero ai Bretoni i precetti
della retorica: � Gallia causidicos
docuit facunda Britannos: E si ha motivo di ritenere che essi
attraversarono lo stretto che separa le due isole, portati dai Bretoni, che li
passarono agli Scoti irlandesi.
Vediamo quindi, nei tempi antichi, qualche
giovane Scoto giungere in Gallia e frequentare le migliori scuole, per poi
tornare nella terra natia, non meno ricca di scienza, per far godere ai compatrioti
simile ricchezza.
Vi era un Gallo-Romano, formatosi nel monastero
di L�rin, san Patrizio che aveva convertito l�Irlanda alla fede cattolica e questo
apostolo, verso la fine della sua vita, aveva inviato presso i Galli il suo
discepolo preferito, san Olcan, affidandogli una missione tutta letteraria.
Olcan aveva attraversato il mare affrontandone i pericoli, per andare ad
ascoltare i dottori dei Galli, facendosi iniziare ai segreti pi� intimi della
scienza, sia sacra sia profana, tornando sulle rive dell�Erin per aprire delle
scuole pubbliche � scholas publicas �
per l�insegnamento comune dei vescovi e dei monaci irlandesi: si era a met� del
V secolo.
Diverse popolazioni barbare avevano invaso e
saccheggiato la Gallia; solo qualche citt� si era potuta salvare dalla completa
devastazione, protetta da misteriosa fortuna. La citt� pi� letteraria
dell�Occidnte era Marsiglia; all�inizio del V secolo; Nestorio aveva scritto
una lettera in greco al papa Celestino I (422-432), il quale il greco non lo conosceva
e non avendo tra il clero latino chi potesse soccorrerlo, era stato chiamato un
interprete da Marsiglia. �
Alla fine del VI secolo, in tutto il territorio
dal Reno ai Pirenei era penetrato il flagello della barbarie;� solo l�Irlanda era stata salvata
dall�invasione, dal mare che la circondava. Ma la sua tranquillit� non era
stata assoluta in quanto principi rivali, spesso vi si scontravano combattendo.
Durante queste lotte civili, gli studi
languivano; fu nel 795 che i Danesi sbarcarono per la prima volta sulle rive
dell�Irlanda e fino alla fine dell�VIII secolo il tesoro dell�erudizione
conservato dai Galli e dagli Scoti, pagani e cristiani, fu preservato da ogni
pericolo di dispersione, mentre nel resto del mondo romano, era travolto dalla
violenza delle conquiste, fino al punto che le regole della grammatica latina erano
state dimenticate, mentre le scuole d�Irlanda rimanevano intatte e fiorenti e
maestri famosi discettavano davanti a una numerosa giovent�, non solo di
eloquenza e poesia latina. ma di grammatica e filosofia greca. Era l�ultimo
asilo delle lettere.
Con la
tesimonianza di Beda, se qualche nobile bretone fosse stato curioso di
sottrarsi al giogo dell�ignoranza, attraversava lo stretto e andava a studiare
in Irlanda e ben istruito, tornava in patria; egli appunto, racconta di �gilvin, che pi�
tardi fu vescovo di Lincoln: Hiberniam
gratia legendi adit, et bene instructus patriam rediit. Alfredo, re di
Nortthumbria, sebbene fosse re, non potendo riunire attorno a s� degli abili
maestri, fece lo stesso
pellegrinaggio con lo stesso scopo.��
Per divenire saggio, un sapiente che fosse avido di
questa gloria, doveva passare qualche tempo in Irlanda:
.............................................
Scottorum qui tum versatus incola
terris
C�lestem intento spirabat corde
sopfhiam.
Cos� si esprime, parlando
di Alfredo, il biografo di san Cutberto; questo
poema si suole attribuirlo a Beda, ma esso � certamente di un Bretone, non di
uno Scoto; uno Scoto, lettore assiduo di Virgilio e Ovidio, non avrebbe mai
violato a questo modo, le regole della prosodia latina (!).
Verso lo stesso tempo, dei monaci
Galli si fecero condurre sulle coste d�Irlanda per chiedere ai loro vecchi
allievi la scienza che essi avevano perduto.
Beda si esprimee cos� con
Agilberto: Legendarum gratia
Scripturarum, in Hibernia non parvo tempore demoratus (La grazia delle leggende
delle scritture, non aveva avuto limitata dimora in Irlanda).
Quando Agilberto apparcve
sul continente verso l�anno 664, meravigli� talmente la Chiesa dei Galli per la
vastit� delle sue conoscenze, che alla morte di Importunio, essa si premur� di
nominarlo vescovo di Parigi.��������� ��
Il bretone Adelmo si sent� celebrare,
verso la fine del VII secolo, la letteratura d�Irlanda: Le flotte trasportavano
legioni di studenti bretoni � �catervatim
istinc lectores classibus adecti confluunt�. E pi� oltre: Hiberni� rus discentium opulens vernansque pascuosa
numrositate lectorum, quemadmodum poli cardines astriferis micantium ornatur
vibrabinibus siderum! (L�Hibernia d�inverno era ricco di
cultura e in primavera abbondante di studenti come i cardini delle stelle sono
ornati dalle vibrazioni degli scintillii delle stelle). �Non � questa enfasi?
La storia sembrava essa stessa ugualmente enfatica, quando parlava
delle scuole d�Hy, di Lismore. di Bangor. di Clonfert, di Clonard e di Armagh,
dove dicono, si trovassero riuniti settemila scolari!
Ma si conoscono meno i maestri irlandesi nella loro patria che
sul continente. ����
COLOMBANO
ESPULSO ��DALLA GALLIA
DA BRUNECHILDE
PER L�AFFRONTO SUBITO
|
D |
alla fine del VI secolo alla fine del IX, l�Inghilterra, la
Gallia, la Germania, l�Italia e la Spagna ebbero numerosi missionari
provenienti dall�Irlanda. Erano dei poeti, eruditi, monaci stranamente anziani,
che confondevano l�apostolato letterario che agitava la Chiesa continentale, con
la novit� dei loro discorsi e presto furono dappertutto respinti, dopo essere
stati accolti con grande favore, non omettendo di lasciar traccia del loro
passaggio nei luoghi in cui essi erano apparsi per qualche istante.��
Uno dei primi e il pi� illustre di questi apostoli era Colombano,
poi santificato, allievo del ginnasio monastico di Bangor. All�et� di
trent�anni, con religiosi della sua nazione, si era recato nelle Gallie per cercare
posti solitari e avendo il gusto per la�
natura selvaggia, istintiva per gli irlandesi, si fermarono tra le gole
dei Vosgi; fu l� che fra le aspre rocce, sotto un sole che illuminava i ricchi
avanzi della civilt� romana, elevarono i monasteri di Annegray, Fontaines e
l�abbazia di Luxeuil, che doveva divenire una delle pi� considerevoli di tutta
la Gallia e, come dichiaravano diversi diplomi papali e reali, la pi� libera, la pi� gelosa, la pi� fiera
delle sue libert�.
Ai piedi
dei Vosgi sul limite che separa il regno d'Austasia da quello di Borgogna non
essendovi altri abitanti che bestie feroci, con i resti di una citt� oltremodo
fiorente fondata dai celti, restaurata dai romani, arrricchita da acque calde,
Luxeuil, era ridotta a un mucchio di ceneri. Ad alcune miglia pi� ad est vi era
un vecchio castello in rov�na dal nome di Annegray (Anagrates) attorno al quale
l'occhio non vedeva che foreste e rocce sterili: � esattamente ci� che cercava e
Colombano vi si stabil� con i suoi compagni.
Annegray
con Luxeuil, apparteneva al regno di Borgogna, e nel 590 regnava Gontrano, che
mor� il 593; in quest�anno i monaci erano duecento (!), tra questi molti
divennero vescovi, a loro volta costruttori di monasteri, tutti, come abbiamo
detto, santificati; nelle vicinanze era stato costruito il monastero di
Fontaines, a tre miglia da Luxeuil, come dice il nome, ricco di acque. A causa
dell�incessante aumento del numero dei monaci a Luxeuil, seguiva il monastero
di Surius; fu a questo punto che Colombano aveva sentito la necessit� di dare
una regola ai monaci e componeva la Regola e il Penitenziale.
Il lavoro
occupava la maggior parte del tempo dei monaci ed era dedicato all�agricoltura:
la terra ricoperta di rovi e di spine era trasformata nelle belle campagne che si
ammiriavano in seguito, frutto di laborioso travaglio; � bene ricordare che
queste centinaia o migliaia di monaci avevano creato da una parte l�agricoltura
e dall�altra le biblioteche conservate con il duro lavoro degli amanuensi (che come
ricordavamo in altra parte, avevano scritto: due sono le dita che scrivono ma � tutto il corpo che duole!),
diffondendo la cultura in Europa.
Maestri
abili e istruiti insegnavano ad allievi che arrivavano da tutte le parti, sulla
base delle Scritture e dei Padri, l�umanesimo e le arti liberali, la geometria,
la retorica, la poetica la matematica. la grammatica ed altro; erano tollerati
gli autori profani, escludendo le oscenit�: Gregorio Magno aveva scritto che �la stessa bocca non pu� cantare nello stesso
tempo le lodi di Cristo e di Giove�.
Qualche tempo dopo (595), Colombano era stato invitato a recarsi
alla Corte di �Gontrano (come detto, morto
il 593), dove regnava il giovane Thierry (Teodorico) II, ma dominava �Brunechilde su di una Corte dissoluta, il cui
esempio, per primo, era dato dallo stesso re. ��
Quando Colombano vi era giunto, �il re era a pranzo con i suoi convitati e lo invitava a sedersi a
tavola e gli veniva offerta una coppa di vino; ma Colombano rifiutava di
partecipare al� banchetto, rompendo la
coppa e gettando il vino perch� proveniente dalle impure mani di un adultero; egli
rimproverava al re il disprezzo che aveva verso la legittima sposa e la vita
sregolata che conduceva fra le concubine. Quando Brunechilde gli aveva
presentato i due figli di Thierry, chiedendogli di benedirli, Colombano si era
rifiutato, negando la benedizione�.
La regina gli chiedeva il motivo del rifiuto e Colmbano �rispose che lo negava� pech� erano nati dalle dissolutezze del padre
con le concubine. Ci� feriva Bunechilde per essere stata lei a prendersi cura
dei figli di Thierry; lei, (scrive Haureau) era circondata da una truppa di
cortigiani; era stata lei a corrompere i costumi della Corte e con questo
odioso artificio era lei a regnare e governare la Corte e il regno, continuando
liberamente nella serie dei crimini (*).����
Colombano in una lettera a Thierry, aveva anche minacciato la
scomunica e gli �aveva espresso le pi�
oltraggiose espressioni che avevano reso furiosa Brunechilde che istigava il
nipote contro Colombano, dicendogli che era evidente che pretendeva di regnare
al suo posto. La regina chiedeva al nipote, che Colombano fosse espulso dal
regno (questa sua reazione ci sembra piuttosto generosa per il carattere di
Brunechilde, facile all�ira e alla eliminazione fisica nei suoi avversari! ndr.).
Erano lettere �versibus
plenas� piene di sferzate, come le chiama il �monaco Ionas,�
cronista della sua vita; Thierry rispose di non essere tanto stolto da
procurargli la corona del martirio e ordin� che fosse prelevato dal convento e
condotto in Irlanda.
I soldati che dovevano eseguire quest�ordine - a cui si vuole che
Brunechilde ne avesse aggiunti altri pi� severi - �gli si
accostarono in ginocchio e il viaggio
di Colombano da Luxeuil fino al mare fu una specie di trionfo da parte del popolo,
che ammirava la sua santit�, ritenendo che avesse il dono della profezia e dei
miracoli.
Giunto nelle terre di Clotario II, Colombano rinunciava a tornare
in Irlanda e con i compagni san Gallo, Magnoaldo, Teodoro, irlandesi come lui,
si recarono in Germania, diretti alle rive del lago Costanza per combattere gli
dei dell�antica Germania; poi attraversando le Alpi, giunsero in Lombardia per
costruire il convento di Bobbio, dove Colombano (615) fiiva i suoi giorni.
*) Il comportamento di Colombano sembra piuttosto temerario, ma
occorre tener presente che i cronisti, questi personaggi santificati li
descrivevano a questo modo per motivi edificanti.
GLI ANTICHI MONACI
IRLANDESI �
�INDIPENDENTI
�DALLA CHIESA ROMANA
|
U |
sher (autore di Sylloge)
e Augustin Thierry, sostenevano che gli antichi monaci irlandesi vivevano con
la Chiesa romana in una indipendenza che rasentava l�eresia: Lanigan, Moore e
M. Oznam, garantivano che i loro sentimenti fossero ortodossi. Occorre
osservare, che questi monaci isolani, seguivano un genere di vita poco conforme
alle pratiche dei monaci di Francia e d�Italia e che su molti punti della
dottrina religiosa, essi professavano delle opinioni assolutamente opposte a
quelle dei cattolici romani.��
Quando nel IX secolo Luigi il Buono, percorreva la Bretagna,
alcuni monaci del Landevenech gli andarono incontro; erano vestiti in maniera
bizzarra e Luigi non dissimul� la sorpresa avuta nell�osservarli. Essi
risposero di aver ricevuto le loro tradizioni monastiche degli Scoti irlandesi.
Ma tutto ci� che poterono dire per giustificarsi, non pot� soddisfare il re
cattolico, che comand� loro formalmente di abbandonare il loro pelo di bestie,
la loro tonsura, la loro regola sospetta di paganesimo e attenersi alle
prescizioni di san Benedetto.
E� stata conservata la regola di san Colombano; essa pareva
essere stata fatta da una confraternita di filosofi. Non era un manuale di
pratica ascetica, ma una raccolta di austere sentenze, improntata ai libri
morali della Bibbia e ai diversi formulari dell�etica stoica.
Le sottigliezze della disciplina romana, le sue esigenze cautelari
che comprimevano tutti gli slanci della fede e regolavano tutte le forme della
devozione, a san Colombano erano rimaste interamente sconosciute. E� da aggiungere
che questo illustre confessore e con lui i chierici irlandesi, ad alta voce
professavano, tanto sulla celebrazione della Pasqua, quanto sulle cerimonie del
battesimo, delle opinioni censurate dalla Corte di Roma e lungi dal farsi
piegare da queste censure, essi avevano risposto con considerazioni altere e
amare.
�La vostra potenza� �
aveva scritto Colombano al vescovo di Roma,�
�durer� fino a quando la vostra
ragione sar� dritta�; � una proposizione hiberniana: la ragione � l�arbitra stessa della fede; ma non insistiamo ulteriormente
su certe differenze dottrinarie; la differenza che esiste tra il gusto
letterario delle scuole irlandesi e le scuole romane � ben pi� notevole.
A Roma e nei paesi dove domina lo spirito romano, i ricordi
dell�antichit� pagana sono esecrati: � Se
si cerca negli antichi manoscritti, � per distruggerli o per evidenziarne i
caratteri e tracciare sugli stessi veleni di preghiere, di leggende sacre. Si
ordina ai neofiti cristiani di fuggire l�impuro contatto dei poeti profani.
San Paolino di Nola diceva al suo maestro Ausone, �Queste Muse che ho abbandonato perch� esigo, o padre mio, che esse
rientrino favorevolmente in me�? I cuori votati a Cristo rifiutano le Muse e
sono ferme ad Apollo... Le occupazioni frivole e gli agi e gli affari e una
letteratura piena di favole, tutto ci� ci � interdetto da Dio: obbedire alle
sue leggi, contemplare la sua luce che oscura gli artifici dei sofisti, l�arte
dei retori, le finzioni dei poeti, ecco il nostro dovere�.
Uno dei papi pi� versati nella conoscenza delle Sacre Scritture,
san Gregorio Magno, osava scrivere a un vescovo: �Fratello, ho appreso ci� che non posso ripetere senza dolore e onta,
che� avete creduto dover insegnare la
grammatica a qualcuno; apprendete come sia grave quanto orrendo (quam grave nefandumque) che un vescovo tratti queste cose, che un
laico deve ignorare !�.
Ora, non solamente san Colombano aveva preso cura di studiare la
grammatica con i migliori maestri, ma egli era venuto sul continente per
insegnarla ai rudi compagni del re Gontrano, proponendosi di addolcire i loro
costumi, coltivando i loro spiriti. Ma vi � di pi�, Colombano oltre che essere
santo, � il pi� grande poeta del suo tempo. I suoi versi non avevano n� la
cadenza, n� il movimento, n� il vigore ingenuo dei versi antichi; ma almeno erano
puri, corretti e facili, qualit� ben rare nel VI secolo.
Come san Gregorio, quanto san Gregorio (la Chiesa li ha
riconosciuti associandoli l�uno all�altro nella falange dei Beati), san
Colombano � un misssionario cristiano, ma egli concepiva la sua missione
raccomandando la lettura degli antichi poeti, quanto quella degli antichi Padri
e invocando l�autorit� di Giovenale con l�appoggio delle massime evangeliche.
Egli aveva scritto un�ode che indirizzava al suo amico Fedolio, pagano e a
imitazione dei greci, cercava di riprodurre gli accordi con la dolce lyra, non
quelli della galante lesbiana, l�illustre Saffo.
A questo culto per le lettere latine e greche (prosegue Firmin-Didot),
vogliamo associare tutti i dottori irlandesi contemporanei di Colombano; ricordando,
qualcuno� di essi come san Roding, monaco
di Tholey, fondatore di Beaulieu in Argonne e san Furcy, fondatore di Lagny che
ci ha trasmesso alcuni versi di san Livino. vescovo d�Irlanda, che predicava la
fede cristiana ai Galli e mor� alla maniera degli antichi confessori.
Si conoscono i versi del nobile vegliardo, in mezzo alle crudeli
angosce della persecuzione, scritti prima del suo martirio, in cui egli si
affligge, nel declino degli anni, con raammarico, di quelli applauditi dai
letterati in Irlanda che avevano incoraggiato il suo debutto. �Il mio animo rattristato ha perduto il dono
delle gioiose melodie�. In lui si ritovano, come ha osservato M. Ozanan, le
reminiscenze della letteratura profana nel sermone di san Gallo, che rifiutava
il vescovato di Costanza.
Cummiano, nella sua dissertazione sulla Pasqua, ci appare come un
prezioso scrittore che preferisce il gioco dello spirito alle buone ragioni
degli uomini.
Pi� erudito di alcuni teologi delle scuole romane, egli conosce
il greco; ma egli � geloso di mostrare i suoi discorsi, irti di motti
inellegibili, ai dottori incaricati di rispondergli. Quando, per esempio, prima
di citare una frase di Origene, egli la chiama �chalcenterus et vere adamantinus�, egli deve essere ben persuaso
che questo termine �chalcenterus
(scritto anche con caratteri greci), non sar� compreso nel continente,
all�infuori di san Gallo e pu� darsi, di Bobbio, colonie hiberniane.
Egli � della stessa idea per un altro termine, �petalicus�, che segue il nome
dell�apostolo san Giovanni,� il cui
significato �, senza dubbio, esiliato.
Ozanam, aveva raccolto diversi scritti composti in Irlanda nel
VII secolo, un� gran numero di questi
ellenismi; egli attesta una profonda conosccenza della lingua greca presso
popoli che� la usano male a proposito.
Si deve segnalare, aggiunge Firmin-Didot, una assai grande
diversit� di fisionomie tra i dottori irlandesi del VI secolo e quelli del VII
secolo. San Colombano e suoi compagni sono dei poeti. Giovanni di Trittenheim
paragona fortunatamente san Colombano al principe dei druidi: � �E� un druida, un bardo (cantore) che celebra sulla moda lesbiana la povert�
monastica o, su un tono pi� grave, pi� solenne, espone la vanit� delle gioie
mondane e mostra al cristiano l�unica via di salvezza, di felicit�, la via
aperta da Cristo�.
Verso la fine del VII secolo i canti dei bardi sono cessati,
l�arena si � aperta alla teologia contenziosa e i discepoli dei bardi sono i
retori liberi che discettano in termini inusitati sulle verit� o sui problemi
della dottrina cattolica; ma questa diversit� non impedisce che abbiano in
comune per le une e gli altri un fondo comune, l�erudizione; poeti o teologi si
popongono come modello il greco.
Nell�VIII secolo sono rimarchevoli le lettere irlandesi di san
Virgilio, vescovo di Salisburgo in Baviera. Il re Pipino desiderando conoscerlo
lo fece venire nella sua Corte e un cronista ci racconta che questo re, ammirando
la meravigliosa erudizione � eximiam
eruditionem (Wiguleus citato da Usher in Silloge),� di Virgilio, lo
tenne presso di s� per due anni interi, senza permettergli di tornare al suo
gregge.
Le lettere apostoliche con le quali san Virgilio era stato
canonizzato, sono dell�anno 1233; esse consacrarono l�omaggio della piet� popolare;
ma fu una consacrazione tardiva. Quando tutto il popolo bavarese era accorso
sui passi di Virgilio, provando il suo rispetto per l�eminente dottore aggiunto
alla falange dei santi, l�arcivescovo di Mayence, Bonifacio e il papa Zaccaria,
lo inviarono a un Concilio in cui fu ritenuto autore di una dottrina perversa e
criminale, per avere, sulla testimonianza degli antichi greci, affermato
l�esistenza degli antipodi (De perversa autem et iniqua doctrina, quam
contra Deum et anima suam locutus est: perversa e iniqua dottrina che parla
male di Dio e dell'anima.... che ritiene che sulla terra vi sia un altro mondo
e altri uomini...(Lettera di Zaccaria a Bonifacio, Usher, in Sylloge p. 35).
Da non dimenticare dopo Virgilio, san Declano, san Alto che condivisero
i pericoli e la gloria della sua misssione in Baviera, e maestro Dobdan,
soprannominato il Greco,
vescovo coadiutore di Salisburgo, poi vescovo di Chiemsee, che
apr� in quest�ultma citt� una scuola pubblica dove attir� numerose legioni di
uditori et agmina discentium quam plurima
habuit.
Nello stesso secolo troviamo Colchus o Coelchu il Saggio,
Cruindmelo e Malrachano, abili grammatici. Coelchu era supremo moderatore di
una delle grandi scuole irlandesi. Un giorno, dicono, viaggiava a piedi, portando
la sua bisaccia in cui teneva i suoi libri, prezioso tesoro; l�accompagnatore,
con rispettosa familiarit� per alleviare il peso del venerabile dottore, si
offre di portare la pesante bisaccia; questo accompagnatore era san Pietro:
tale � la leggenda irlandese.
I papi riducevano e qualche volta maledicevano, le scienze
profane; ma ecco san Pietro che si opponeva ai papi. Non si sa niente n� di
Cruindmelo n� di Malrachano; tantomeno si trova qualcosa nei loro scritti,
nelle pergamene del IX secolo e la sicurezza e l�estensione delle loro
conoscenze prova che essi siano irlandesi. Malrachamo, versato in tutte le
sottilgliezze della grammatica, cita frequentemente Donat e questo Virgilio di
Tolosa, di cui il cardinale Mai ha pubblicamente riconosciuto le dissertazioni
grammaticali in qualche manoscritto del Vaticano.
Ma ci� che � particolarmente irlandese nel suo metodo, � che si
va spesso dal greco al latino, e spiegando volta per volta il processo delle
due lingue, essi insegnano volta per volta il procedere delle due lingue;
insegnano volta per volta, l�una e l�altra con ingegnosi e sottili rapprocci.
Cruindmelo esponeva ai suoi allievi le regole e la prosodia
latina; egli conosceva il risentimento dei dottori romani per gli antichi
poeti. Sant�Ouen, nella Vita di san Eloi,
lo chiama, con proprio termine, scellerato. Odone di Cluny non lo tratta meglio
quando paragona Virgilio a un bel vaso, all�interno del quale si agitano
orribili rettili. Gli insegnanti irlandesi non avevano tanti scrupoli. Ecco il
debutto di Cruindmelo
Discite me,
pueri, versus (qui) scribere vultis
Nem veterum
rite carminam prisca sequor
e per completare l�impegno preso con questo esordio, egli citer�
spesso i monaci Sidelio, Prospero o Virgilio. Ci� che egli prende dai grammatici,
interessa maggiormente, poich� ci rivelano i suggerimenti, i consigli della sua
rara esperienza.
Oltre a Donato, Prisciano e Virgilio di Tolosa vi sono Sergio,
Pompeo, Onorato, Massimiano, Paolino, Teodoro, Palemone, Maurio, Servio,
consultati da un dottore italiano o gallo, dello stessso secolo o del secolo
seguente; di questi grammatici antichi e moderni, egli non conosce che
Prisciano o Donato e la sua competenza didattica non � superiore alla sua
erudizione. �
LA SCUOLA PALATINA
ALLA CORTE
DI CARLOMAGNO
E I BATTIBECCHI
NELLA SCUOLA
|
L |
�VIII secolo finisce con Carlomagno che regna sull�Austrasia e
sulla Neustria; l�Italia lo saluta come l�erede dei Cesari e il suo braccio
protettore o vincitore, si estende dai confini della Sassonia al versante dei
Pirenei.
Al di sopra delle sue imprese egli dispone la restaurazione degli
studi antichi: per usare una espressione di Alcuino, egli vuole fondare una novella Atene.
Gli studenti non mancano; egli stesso� decide di entrare nella faalange degli studiosi.
Ma ci� che � difficile � trovare dei maestri. L�Italia fornisce Paolo Diacono e
Pietro di Pisa, letterati di rinomanza; Teodulfo giunge dai confini della
Settimania per essere il Pindaro della Corte di cui Alcuino � l�Orazio.
Gli eruditi saranno inviati dall�Irlanda. Cos� l�Irlanda,
risparmiata dalla barbarie � incaricata particolarmente della educazione dei
barbari e trasmettendo al mondo nuovo le tradizioni del mondo antico, essa
viene a sollecitare l� unione dell�uno e dell�altro.� Ma qual�� l�impedimento di questa unione?
Dopo la fine del V secolo si � ben compiuto il cambiamento nello
spirito, nei costumi delle nazioni occidentali. Frattanto, in mezzo a tutte
queste rivoluzioni, Roma non ha cessato di lavorare per riprendere l�impero del
mondo e con i suoi costanti sforzi un certo ordine si � ristabilito;� una certa pace, fondata� sulla servit� delle coscienze, ha rimpiazzato
la confusione e la turbolenza che era seguita alla barbarie.
Esisteva una ortodossia romana. Ma la sua dominazione non si era
estesa fino all�Irlanda. Ci� che la dominava ancora era l�ellenismo
alessandrino, con la sua dotta sottigliezza, la sua dialettica litigiosa e
temeraria, il suo entusiasmo per la sua libert�. �Abbiamo gi� accennato alla contrariet� di queste due tendenze�,
precisa Haureau. �Essa divamper� pi�
ancora quando i rappresentanti dell�una e dell�altra si incontreranno sullo
stesso teatro�.
Questo teatro � Carlomagno che viene ad alzarlo: esso si chiama Scuola di palazzo.
�Seguiamo la
folla dei principi, principesse, guerrieri e clero che la frequentavano. I
maestri latini e maesri greci occcupavano�
le scene rivali e noi andiamo a sentirli contraddire e ingiuriarsi�. Ci� sar�
il loro preludio. Pi� tardi essi verranno a proscriversi. Uno degli storici di
Carlomagno, il monaco di San Gallo, raccontava in termini primitivi, l�arrivo
di due irlandesi alla Corte d�Austrasia. I due viaggiatori si erano fermati in
una piazza pubblica e, in pieno mercato, non mostravano alcuna mercanzia, ma si
facevano conoscere dalla folla per la singolarit� del loro vestiario che attraeva
e riempiva di meraviglia: �Se qualcuno
desidera della scienza che conosciamo, noi la vendiamo�. Essi dicevano.
�Il magnanimo Carlo, avendo
sentito parlare di questi stranieri, li chiamava presso di lui, li interrogava
e, meravigliato del loro sapere, affidava alla loro disciplina una numerosa
giovent��. ���
Questo racconto non pu� essere non conforme alla verit�; pi�
tardi era stato abbondantemente e vantaggiosamente commentato, scrive� Haureau. Ma � certo che vi erano diversi
irlandesi che reggevano la Scuola
palatina e che essi esercitavano una grande influenza. Il pi� celebre era
il grammatico Clemente, soprannominato l�Iberniano.
Per molto tempo si era creduto che di questo Clemente non fosse rimasta alcuna
opera; ma nel Catalogus librorum Angliae
et Hiberniae, pubblicato a Oxford nel 1697, era offerta la seguente menzione
dei manoscritti di Vossius: �Excepta e
Grammatica antiquis, a Clemente quodam collecta�. Ma questa indicazione,
gi� raccolta dagli autori dell�Histoire
Litt�raire,� appare ben vaga e
potrebbe essere fallace.
�Una indicazione pi�
precisa (prosegue Haureau) ci � stata fornita da Sinner, nel catalogo di
manoscritti di Berna, egli designa: Clementis
Scoti de partibus orationis; ma si tratta di un manoscritto incompleto, al
quale mancano l�inizio e la fine. Intanto Sinner cita qualche frase: �Major populus et magis egregiis artibus
pollens Tusci fuere quidem natura linguae suae ctc�. ����
Infine, una paziente ricerca, ricompensa il successo� (riferisce Haureau) e ci ha fatto
recentemente ritrovare questa frase nel volume 1188 del fondo di San Germaine
(fol. 131 verso), �in mezzzo a una dissertazione anonima sulle
parti di un discorso intitolato �Ecloge
de libris Grammaticorum�. Possediamo questo scritto di Clemente di cui fino
ad oggi l�esistenza ci era sembrata dubbia e i mns. di Vossius, Berna,
Saint-Germaine, sono tre esempi di una stessa opera. �����
E� un dialogo pieno di questioni ardue e risposte che rivelano un
fondo di conoscenza straordinaria per quel tempo (prosegue Haureau).
L�erudizione dell�autore � dimostrata dal gran numero delle autorit� che egli richiama (*). Quanto
al metodo egli � ancora pi� sorprendente; egli conosce il greco e sa ben
riprodurre in lettere greche dei versi di Omero. Egli assicura �che in tutte le scienze i greci sono i suoi
maestri ed egli segue i loro insegnamenti �Gr�ci quibus
in omni doctrina doctoribus utimur�; infine questa lunga dissertazione
sulle parti del discorso in cui Clemente pareva avesse condensato il suo
sapere, � una� costante comparazione tra
i principi comuni e i differenti idiotismi della lingua greca e latina.
Se Clemente fosse un filosofo, secondo l�accezione moderna di
questo termine, non lo dimostra nella sua grammatica; inutilmente (scrive
Haureau) abbiamo cercato qualche sua sentenza filosofica nella sua grammatica.
Certamente si ha ragione di credere che presso la Corte di Carlomagno egli
aveva offeso pi� di una orecchia con i suoi liberi discorsi e per la� semplicit� del suo ellenismo. Teodulfo lo designava
fra i nemici, per la sua fama come maestro Scoto, gran sapiente, ma aggiungeva,
da gran pedante, di cui ciascuno alla Corte rilevava l�umore litigioso e lo
malediceva.
Alle imprecazioni di Teodulfo, si aggiungono le rimostranze, non
meno rimarcabili del maestro Alcuino. Alcuino, nato in Gran Bretagna da una
famiglia sassone, era un allievo della scuola di York e come tutte le persone
del suo paese, egli provava per gli Scoti, un sentimento che non fosse molto
lontano dall�avversione.� �
Dopo aver diretto per qualche tempo la Scuola di Palazzo, egli si
era ritirato nel monastero di Saint Martin de Tours, dove continuava a formare
allievi; ma era venuto a conoscenza di una spiacevole storia; la scuola �era stata sedotta dal brillante sapere di un
Irlandese e l�influenza di questo dottore, nella scuola che aveva lasciato, era
divenuta preponderante. Egli se ne affliggeva e si allarmava; lui stesso scriveva
al re Carlo: �Andando via avevo lasciato
presso di voi dei Latini; non so chi li abbia rimpiazzati con degli Egiziani�.
Questa classificazione (scrive il citato storico) � nel contempo
ingegnosa e precisa. La citt� sapiente d�Egitto, era Alessandria e l�eresia
degli Scoti, relativamente alla Pasqua, la loro boria sofisticata, il loro metodo,
le loro dottrine e, in una parola, tutto il loro ellenismo, riprendeva bene la
tradizione alessandrina; Alcuino, illustre rivale contemporaneo di Clemente,
aveva chiamato i maestri irlandesi con il loro vero nome. La loro patria era
l�Egitto ed erano stati introdotti con frode in una scuola di fondazione
latina; e l�Anglo-Sassone (Alcuino), nel fervore del suo zelo per la causa dei
Latini, chiedeva che essi fossero scacciati.
Il IX secolo cominciava per gli Scoti con un lungo periodo d�afflizione
domestica, con i� Danesi che si erano
stabiliti� nella loro patria.
Ma nello stesso periodo e per la stessa causa le emigrazioni si
moltiplicavano; gli insegmamti irlandesi andavano a propagare dappertutto il loro
sapere e le loro dottrine; dappertutto li ascoltavano, li ammiravano, li ricoprivano
di onori.�
Fra questi illustri emigrati, dobbiamo contare il monaco Dicuil, autore
del �De mensura orbis terr��
pubblicato da� Walckenna�r nel 1807
e abilmente commentato da Letronne, probabilmente nel 1814; si supponva che
Dicuil fosse abate di Pahlacht, ma niente provava che egli avesse lasciato
l�Irlanda.
Allo stesso tempo, riferisce�
Haureau, apparteneva l�interprete Claudio, che aveva lasciato delle
glosse su quasi tutti i libri delle sante Scritture� e il matematico Gildas, raccomandato da Bale
e da Usher. Non si sa se Gildas e Claudio abbiano viaggiato. Ma si vede errare,
pi� o meno lontano dalle rive iberniane, il grammatico Dungal, incaricato da
Carlomagno di istruire i giovani di Pavia. Lo stesso che rifiutava gli errori
di Claudio da Torino e senza dubbio lo stesso che, per rassicurare l�ignoranza
allarmata del grande Carlo, aveva scritto una lettera sull�eclisse dell�819; Killak,
abate di Kildare e il vescovo di Blatmac erano andati a istruire gli Scoti Albanesi;
l�abate Indract, il beato Ultan e il monaco Dubslan, Machbeth, Malmunn, avevano
visitato e catechizzato l�Inghilterra, l�anacoreta Eusebio, il beato Marcello, e il vescovo
Erlulfo e Cortilla, percorrevano la Germania.
E� soprattutto nelle Gallie che si incontravano questi dotti
pellegrini. Carlomagno li proteggeva contro lo
stesso Alcuino: Luigi il Buono (v. citato Art. Carlomagno ecc.) aveva
avuto per essi la stessa stima; Carlo il Calvo (idem) li invitava alla sua tavola, trattandoli come amabili compagni
e accordava loro, ci assicurano, precisa Haureau, il diritto di prendersi beffe
familiarmente di lui. Ci fanno sapere di Heiric d�Auxerre, proveniente dalla
Scuola di Palazzo e raccontano, ci� che egli aveva visto: �Parler�. diceva. dell�Irlanda,
che disprezzando i pericoli del mare, � emigrata tutta intera, sulle nostre
spiagge con le sue truppe di filosofi?�. E� chiaro che questo linguaggio
fosse iperbolico. E certo che sotto il regno di Carlo il Calvo un gran numero
di Iberniani erano apparsi nelle Gallie e noi non rimpiangiamo mai tanto, di
averne conosciuto solo tre, Elia, Mannone e Scoto Erigena (Irlandese).
Gli autori di Gallia
Christiana, non indicano in quale Scuola avesse insegnato Elia; ma essi
attestano almeno, che egli avesse avuto un meraviglioso successo �in Gallia mirifice scholas rexit�. Il
suo merito fu ricompensato; egli mor� vescovo d�Angoul�me.�
Bisogna ammettere, in base alla tesimonianza di un anziano,
citato dal fratello San-Marte, che il dotto Heiric fosse il discepolo preferito
di Elia. Questo anziano, erigendo la momenclatura dei primi reggenti delle
nostre scuole, aveva commesso evidenti errori. In particolare, per quanto
riguarda Heiric ed Elia, scrive Haureau, egli non era stato forse che male
informato; le glosse di Heiric, smaltate�
di motti greci con una fedelt� contestabile, ci fanno conoscere che egli
avesse compiuto studi con un maestro irlandese.
Val�re Andr�, attribuiva a Mannone dei Commentari sulle Leggi e
sulla Repubblica di Platone. Questa attribuzione � erronea; ma n� il merito di
Mannone, n� il suo soggiorno nelle Gallie, sono cose dubbie. Egli era stato
prevosto dell�Abbazia di Saint-Oyand de Joux, che prese pi� tardi il nome di
Sain-Cloud o diocesi di Lione ed egli mor� il 16 agosto 880. Questa data appariva
certa.�
Un manoscritto del IX secolo, iscritto sotto il numero 2832 dei
fondi del re, alla Biblioteca reale (Parigi), (scrive Haureau) conteneva dei
poemi di Democrito, san Cipriano, Depranius, Vandebert, Teodulfo, e sui primi
foglietti di questo manoscritto, si leggeva: Voto bon� memoria
Mannonis. Liber ad sepulchrum sancti Augendi oblatus; libro
offerto da Mannone al monastero di Saint-Oyand. Noi ritroviamo la stessa
postilla in una raccolta della biblioteca della Scuola di medicina di
Montpellier, sotto il numero 157 e, in un manoscritto di Troyes che contiene il
commentario di Floro, vescovo di Lione, sulle epistole di san Paolo. Mannone
verso la fine della sua vita aveva legato tutti questi libri, all�abbazia di
Sain-Oyand, dove, nell�assenza dell�abate titolare, l�arcivescovo Remy,
occupava la prima dignit� claustrale.
E� un �ramamrico (conclude
Haureau) non avere altri insegnamenti da produrre su un uomo che sembrava aver
goduto di un s� gran nome. Sperando che una nuova ricerca possa essere pi� completa
e che le biblioteche d�Irlanda, oggi cos� negligentemente ancora esplorate, un
altro Usher, faccia emergere un giorno uno scritto di Mannone.
In attesa di questa scoperta, conclude Haureau, almeno Giovanni
Scvoto Erigena ci fa sapere quale fosse il suo carattere, quali furono le
opinioni dei filosofi irlandesi del IX secolo. Se non abbiamo altri libri che i
suoi, da poter essere informati a questo riguardo, essi sono tali da essere
sufficienti.� ������
*) I grammatici che egli cita sono: Comminianus, Maximianus,
Papirinus, Sulpicius, �neas, Servilius, Lucanus, Gelvidius, Etherius,Pr�torius �Hilarius, Glengus, Galbungus.
�
GIOVANNI SCOTO
ERIGENA CHIUDE
IL CICLO DELLE
SCUOLE IRLANDESI CHE
SI CONFONDONO
CON LE LATINE
�����������
|
G |
iovanni Scoto (805-877 c.ca) �conosce
bene il greco (scriveva il benedettino Jean Liron nel 1734), e non quanto Beda, Alcuino, Heiric, o Remy
d�Auxerre e tanti altri apprendisti ellenisti della Scuola latina, che, per
aver appreso qualche vocabolo greco, facendo commercio con gli irlandesi, fanno
una gran parata e si tradiscono subito con i pi� buffoneschi errori e
l�imperfezione del loro sapere�.
�Egli
conosce il greco quanto un erudito del XVImo secolo - proseguiva
il benedettino - �e le sue traduzioni delle opere di Dionigi sono ancora oggi in tutte le
mani. E� oramai da tempo che la stampa ha moltiplicato i suoi esemplari�.
Ma Scoto non era stato solo un grammatico; egli � stato un
filosofo. Aveva commentato Marziano Capella e i termini della sua glossa e ci�
che concerne la dialettica, sono di una singolare energia.
Egli non si accontenta di essere realista, � ad oltranza come
Spinoza. Dopo aver affermato l�unit� sostanziale di tutti gli esseri, riconosce
che essi differiscono in qualcosa; ma per dichiarare subito che tutta questa
differenza � semplicemente superficiale. Che tesi! Che blasfemia essa contiene!
Giovanni Scoto ha letto Platone (prosegue il benedettino), almeno
il Timeo di Platone e nel suo
trattato �Della divisione della Natura�
egli lo cita spesso. Platone � il suo maestro ed egli lo intepreta in modo da
far credere che egli ha avuto pi� di un incontro con lui sotto le ombre
dell�Accademia (l�Areopago). Ma ci� nonostante, non � affatto un pagano. Il Dio
che egli venera non � Giove; egli ha dovuto abbandonare questo nome, che
ricorda troppe avventure oscene.
Con i cristiani Giovanni Scoto proclamava che l�unico autore di
tutte le creature, � personificato sotto tre ipostasi diverse. Ma, non per
questo egli sia meno istruito su tutto ci� che concerne la credenza, la fede cattolica, e non si rammarica di essere in
vantaggio: La filosofia, (egli dice
in �De Divina Pr�destinatione�), � lo studio della saggezza; non � una cosa e
la religione un�altra. Ci� che � trattare della filosofia,� se non esporre i precetti della vera
religione (*), seguendo la quale noi adoriamo�
umilmente e perseguiamo il mistero nel mistero, la sovrana e prima causa
di tutte le cose, Dio? Dande consegue che la vera filosofia � la vera religione
e reciprocamente, la vera religione � la vera filosofia�.
Ma � una assimilazione inconveniente che rivolta la chiesa di
Ario, come quella di Attanasio e contro la quale tutta l�autorit� protesta con
uguale energia. �L�autorit�, egli
risponde, procede dalla dritta ragione, e
non vale la ragione dell�autorit�. Ora, tutta l�autorit� di cui i decreti non
sono approvati� dalla ragione, � una
autorit� senza valore, tanto che la dritta ragione stabilisce come la fortezza
inespugnabile dietro il rimparto delle sue forze, non ha bisogno di essere
protetta con il soccorso dell�autorit��.
Quale � questo strano linguaggio? Se la Chiesa lo intende, essa
si incrudelisce. Giovanni Scoto, prosegue: �Io
non sono totalmente spaventato dalla autorit� e non temo la furia degli spiriti
intelligenti, da esitare a ritenere tanto in alto ci� che la mia ragione
discerne chiaramente e dimostra con certezza�. �
La libert� di queste dichiarazioni � sorprendente, scrive Haureau.
Come � gi� stato sottolineato, l�originalit�, l�insubordinazione tradizionale
dei maestri irlandesi i quali non si attendono certamente di vedere un
contemporaneo, un commensale di Carlo il Calvo, dire delle cose cos� penetranti,
con un tono cos� risoluto. Sono l�, seguendo la Chiesa tante blasfemie; per
intendere rinnovarle egli fa discendere la serie dei secoli per giungere fino
al filosofo di Malmesbury (Thomas Hobbes 1588-1679).������������������������������������������������
Tali principi (scrive Haureau) dovevano condurre Giovanni Scoto
al disconoscimento di tutta la teologia e di tutta la filosofia cristiana.� Egli poteva ancora scegliere fra diversi
sistemi raccomandati al nome della ragion pura e preferirne i pi� timidi o i
pi� temerari. Ma la sua dottrina � precisamente l�ultima parola della antica
audacia. Non � la dottrina di Aristotele, egli la disprezza,� e neanche quella di Platone: egli va ben
aldil�.
E� alla lettera quella di Proclo, il panteismo arrogante. senza
misura e senza freno. �Egli � molto
curioso� dice Deg�rando (**), �di
vedere in mezzo a questa generale ignoranza, in un�epoca in cui la sfera di
studi del filosofo francese sia cos� stretta, un uomo. un solo uomo, �lanciarsi nella pi� alta regione delle
speculazioni astratte; egli � molto curioso di vedere la filosofia del medioevo
esprimersi per una concezione cos� singolare. ... L�apparizione di un tal uomo,
in una tal epoca �, ad ogni riguardo, un fenomeno straordinario: sembrerebbe
incontrare un monumento artistico in mezzo alle sabbie del deserto�(Histoire
compar�e des systemes de philosophie).
Se Giovanni
Scoto, reggente della Scuola palatina, avesse
potuto limitarsi a� occuparsi di questo
incarico e rimanere estraneo agli affari della Chiesa, la Chiesa avrebbe potuto
lasciarlo continuare �in pace e in
libert�, fare dei discorsi di cui essa non era capace di apprezzarne la
portata.
Ma su invito dello stesso Carlo il Calvo, Giovanni Scoto aveva
osato dichiarare i suoi sentimenti sulla controversia dogmatica provocata da
Gottschalk (***). Dei clamori si elevarono subito contro l�Egiziano fazioso ed
empio (v. sopra, Clemente); la Chiesa latina si sollev� tutta intera e si
appell� agli abusi. �
Quali furono gli esiti di questa tempesta? Cosa divenne la
filosofia, abbandonata da tutti, perseguita con tanta chiasso? Si sa: egli
scomparve e la storia non ritrova pi� le sue tracce. Con lui, l�ellenismo
irlandese � vinto, proscritto, e ormai la Scuola
palatina non offrir� pi� altri Erigeni.
Egli � riconosciuto dappertutto, � proclamato come una pubblica peste,
dir�:� res hostis atrox-cosa da
nemico atroce, come diceva Teodulfo e che il fedele cristiano doveva
sfuggirlo con orrore.
Nei primi anni del XII.mo secolo, la Chiesa, ricercando, per
darli alle fiamme vendicatrici, tutti gli scritti che avevano potuto contribuire
a far nascere l�eresia che porta il nome di Amaury de B�ne e David de Dinant,
il trattato ��Della
divisione della natura� fu
segnato come la vera fonte dell�errore e fu allora solennemente condannato.������������������������������������������������
In quest�epoca le scuole d�Irlanda non erano pi� come quelle
descritte, sottomesse
all�autorit� romana, esse avevano lasciato da parte Platone e Proclo per
adottare Sant�Agostino e San Gregorio. Il pi� brillante, come sembra, dei
maestri irlandesi, Giovanni Scoto � l�ultimo rappresentante della loro
indipendenza comincia a prevalere e i filosofi platonizzanti cedono il posto ai
teologi ortodossi: � dunque qui che si arresta la storia sommaria delle scuole
d�Irlanda che perdono il loro nome proprio e si confondono con le altre scuole
latine.
�*) �Chi scrive, come abbiamo visto, � un
benedettino il quale ripete lo stesso errore della Scolastica, fondata proprio
da Giovanni Scoto, che voleva tener distinta la Filosofia dalla Religione, secondo
i principi dell�Areopago, la Scuola ateniese
di Platone e Aristotele e non come l�aveva impostata Plotino (nelle Enneadi) con il neoplatonismo che aveva indirizzato
verso l�apparenza cristiana, la filosofia platonia�ca; ma Scoto non era
riuscito nel suo intento, perch� questo indirizzo nella Scolastica era
continuato fino alla sua� fine (v. nota ***
in Parte seconda).
**) Joseph Marie de G�rando ( 1772-1842), barone di origine
italiana.
***) In latino Godescalcus, Gottschalk (804-870 c.ca), monaco
dell�abbazia di Saint-Bertin, con la sua tesi sulla pr�destinatione
aveva anticipato il protestantesimo.
�
I DUE MOTORI
DELLA CULTURA
IN OCCIDENTE:
RINASCENZA E
INVENZIONE DELLA
STAMPA
|
I |
�due
grandi motori della cultura intellettuale in Occidente (scrive Firmin-Didot)
furono la Rinascenza accompagnata dalla invenzione della Stampa che aveva salvato
e propagato i capolavori dell'antichit�. La maggior parte di questi capolavori
erano costituiti dai tesori della letteratura greca, la figlia pi� illustre
dello spirito umano, che avevano trovato il loro entusiata propagatore in Aldo
Manuzio.
La
lingua greca, sola tra altre lingue antiche, dopo tante vicissitudini era
riuscita a salvarsi e conservarsi per tremila anni, consegnandoci, come un
astro sorto ai confini tra l'Asia e l'Europa, Omero, in tutto il suo primitivo
splendore.
E
si pu� dire con Bossuet che: �Tutto
l�Oriente, riconoscendo la Grecia, apprese la sua lingua�. A ci� si pu�
aggiungere che nell�arco� di tre secoli
si videro brillare gli astri di Eschilo, Sofocle, Euripide, Aristofane,
Erodoto, Tucidide, Senofonte. Eschine, Demostene, e infine Platone ed
Aristotele ... senza contare i successivi, dei quali solo come esempio
indichiamo Euclide.
Vinta
dalla superiorit� del genio politico e militare di Roma, la Grecia soccombeva a
questa duplice stretta, e perdendo la sua perigliosa libert�, perdette anche le
sue nobili ispirazioni, Ma conserv� il primo rango nelle lettere e nelle arti e
il suo appassioato gusto per il bello, inerente alla sua natura, alle sue
istituzioni, al suo clima. Si vide allora questa potenza intellettuale e
civilizzatrice che la Grecia aveva esteso a tutto l�Oriente, esercitare lo
stesso impero su Roma, ancora pressoch� barbara e sui popoli sottoposti alla
sua dominazione; sotto questa influenza, Roma, che da lungo tempo aveva
improntato alla Grecia le sue istituzioni politiche, si fece greca: da allora
la conoscenza della lingua e letteratura greca, a Roma, era divenuta frequente.����
Ben
prima della prima guerra punica (264-241) molti romani comprendevano e
parlavano la lingua greca; la pi� antica storia di Roma � dovuta a Quinto Fabio
Pittore che l�aveva scritta verso il 215 avanti la nostra era, in lingua greca,
secondo Dionigi d�Alicarnassso. Nel 164 Tiberio Grcco, il padre dei due
tribuni, inviato come anmbasciatore in Asia Minore, si era fermato a Rodi dove
pronunziava in greco, un discorso che esisteva ancora al tempo di Cicerone. ���
Nel
secondo secolo, prima della nostra era, la conoscenza del greco era
obbligatoria nella formazione di una buona educazione. Atene divenne la scuola
dei romani e ben presto, durante il secolo di Augusto (primo sec. prima della
nostra era) illustrato da Cicerone, Virgilio, Orazio, entusiasti ammiratori di
Omero, di Esiodo, di Teocrito, di Demostene, di cui essi furono imitatori; si
rinnovava nell�impero romno, il secolo di
Pericle (citato da Voltaire nel Secolo
di Luigi XIV): sotto il regno di Augusto per le donne costituiva motivo di
raffinatezza parlare in greco.
L�entusiasmo
era stato tale che Orazio ed altri autori, avevano chiesto all�imperatore di
trasportare la sede dell�impero sulle rive troiane. Cicerone diceva che: �Le opere greche sono lette presso tutte le
nazioni e i testi latini sono
ristretti
nei limiti dell�Italia� (ma
sappiamo che, per loro fortuna, avevano otrepassato quei confini! ndr.).
La
venerazione di Roma per il genio greco, scrive Firmin-Didot, aveva contribuito
alla diffusione della letteratura greca nel mondo civilizzato e fu allora, dopo
la caduta dell�indipendenza greca, che presso i romani, africani e asiatici si
pubblicarono importanti opere in lingua greca e continuarono in questa
germinazione.
La
conoscenza della lingua greca era penetrata in Armenia e presso i Parti. Alla
fine del primo secolo prima della nostra era, Crasso aveva ricevuto due greci che
in nome del generale Sur�na, parlando il greco, lo avevano invitato a un
incontro. ��
Nella
drammatica esposizione fatta da Plutarco (nella Vita di Crasso), delle nozze della sorella di Artabaze, re
dell�Armenia, con Pacorus, figlio di Orod�s l�Arsacide, re dei Parti, nozze
celebrate alla Corte armena, si assiste al gran ruolo giocato dalla lingua
greca; �durante le feste date dai due re,
si erano recitate poesie greche (Arabaze in questa lingua aveva composto
tragedie, storie e arringhe); quando gli era stata portata la testa di Crasso,
un attore di nome Giasone gli� aveva
recitato la scena di Agav� delle �Baccanti�
di Euripide e tutti i convitati erano stati in grado di capire il greco.
Nel
secolo di Augusto, a Roma si presenta un periodo di decadenza della lingua
greca, ma il diffondersi del cristianesimo favorisce il ritorno della lingua
greca; il paganesimo, battuto dai Vangeli, ripara nella filosofia di Platone.
La magia, lo stile e l�elevatezza delle idee di questo genio, esercitano una
potenza seduttrice sugli spiriti, al punto�
che il platonismo assorbe il mondo romano durante tutto il secondo
secolo, per continuare ancora nei secoli successivi. Tutte le branche della
letteratura greca si risvegliano, tanto che le lettere latine cadono nella
mediocrit� e il genio greco produce, nei secoli successivi (I e II n. e.) opere
rimarchevoli.�� �
L�influenza
della letteratura e filosofia greca, prosegue Firmin-Didot, si accresce nelle
classi pi� elevate sotto il regno di Antonino e quando sale sul trono
l�imperatore-filosofo Marco Aurelio, scrive le �Massime� ispirate da Zenone e Platone e due seoli dopo l�imperatore
Giuliano, al latino, preferisce la lingua greca per la difesa del politeismo e
per gli altri suoi scritti.������������ �
La
giovane societ� cristiana, disdegnando le lettere profane e assumendo per
missione di combattere gli errori, si
rifugia nella filosofia (che, come abbiamo detto , diventa Teologia) poggia le prime pietre della letteratura sacra, che trova
da lottare con le idee pagane, portando il movimento letterario sul terreno
della polemica. Le opere profane troveranno minor eco, ma � il genio greco e la
sua filosofia che planano sul campo di battaglia.
Il
platonismo (nella forma cristiana!) diventa talmente potente nel terzo secolo,
da sedurre pi� di un Padre della Chiesa nascente e la letteratura pagana, come
detto, entra nell�ombra, per cedere il campo alla letteratura sacra e l�ora del
trionfo della Croce � il segnale della sua rapida fine.
Il
fanatismo religioso � al suo debutto, e i prelati sono costretti a leggere, e
lo fanno volentieri, le opere profane; ci� che affligge san Girolamo e porta la
Chiesa a pronunciare nel Concilio di Cartagine (*), l�interdizione ai vescovi
della lettura dei libri pagani, in quanto il loro esempio avrebbe potuto
portare a risultati funesti!
Lo
stesso Gregorio Magno aveva contribuito alla distruzione di molte opere della
letteratura antica per le quali i suoi subordinati si mostrarono ben lieti di
assecondarlo nell� eseguire le sue disposizioni.
*)
L�autore del testo, Firmin-Didot, non precisa quale� fosse il Conclio di� Cartagineal quale attribuisce questo divieto,
che non risulta nei primi due del 411 e 438.
�
�L�ELLENISMO IN ITALIA
PRIMA
�DI ALDO MANUZIO
|
L |
�ora del risveglio giunger�
nella terra classica dove il passaggio di due civilt� ha lasciato tracce
profonde; lo spettacolo dei ricordi dell�antichit�, aveva colpito la viva
immaginazione degli italiani e sviluppato presso di loro il sentimento del
bello. La loro genialit, scrive Firmin-Didot, era ispirata dalla contemplazione
dei monumenti dei secoli passati e allo scomparire della barbarie in Italia, la
Rinascenza comincia con opere di architettura e scultura; da quel momento essa,
con ardore giovanile, si mise alla testa del movimento intellettuale, prendendo
quel nome; il ritorno verso la latinit� letteraria antica, fu rapido a causa
della stretta parentela che la univa alla lingua italiana.
Meno sottomessa alla influenza della scolastica, l�Italia percorrer� pi�
velocemenmte di tutti gli altri Paesi, la strada che condurr� all�affrancamento
degli spiriti. Pi� a contatto con l�Oriente, essa arriver� per prima� a scrollarsi dal giogo dei pregiudizi e dei
risentimenti religiosi, per� porre in
onore l�ellenismo.
Sarebbe interessaante e istruttivo, scrive
Firmin-Didot, tracciare nei dettagli, il sentiero progressivo degli studi greci
in Italia, dopo la caduta dell�impero ronano; ma sarebbe difficile sperare di
trovare uno zelante ellenista che possa darci un�opera come quella che Hegger
ci aveva dato sull��Hellenisme en France�
(l�Accademia di Torino aveva messo a concorso il soggetto: L�Ellenismo in Italia, ma non si erano
presentati concorrenti).
Dal mio
canto, precisa
Firmin-Didot, cercher� di menzionare sommariamente
ci� che � avvenuto in Italia, prima di Aldo Manuzio, al fine di far apprezzare
le difficolt� dei suoi lavori, il fragore del suo successo e mettere in
evidenza, in mezzo al movimento letterario del XVImo secolo, questa simpatica e
grandiosa personalit�, in tutta la sua semplicit�.
Gli eruditi dimostrano che la lingua greca non ha
mai cessato di essere conosciuta in Italia durante tutta la durata del
medioevo, grazie alle relazioni commerciali, politiche e religiose con la
Grecia e al possesso di qualcuna delle sue province (citt� marittime della
Magna Grecia).
Non bisogna per� dimenticare che si tratta, pi�
sovente, di lingua parlata, quella volgare di Bisanzio. Quanto a quella
letteraria antica e a certe nozioni della letteratura greca, si potranno
indicare pochi esempi nel corso del medioevo, sia in Italia che nel resto
dell�Europa.��
Si trovano in Italia molti manoscritti,
sottratti all�opera devastatrice delle invasioini, ma ben pochi uomini in grado
di decifrarli e comprenderli. Nell�VIII secolo, il papa Paolo I aveva inviato a
Pipino il Breve, diversi nmanoscritti greci, tra gli altri la Dialettica di Aristotele. Nel Xmo
secolo, il papa Silvestro II (Gerberto d�Aurilliac, ritenuto mago: 999-1003),
parla dell�abbondanza di manoscritti antichi in Italia. Didier (Dauferio),
abate di Monte-Cassino (pi� tardi papa col nome di Vittore III, 1086-87)
arricch� nel IX secolo la biblioteca del monastero, di manoscritti portati da
Costantinopoli.�����������������������������������������������������
Ma, chi troviamo tra i dotti italiani, istruiti
nella lingua e letteratura greca? Dopo Boezio e Cassiodoro (VI sec.) non troviamo che Pietro di Pisa e Paolo Diacono,
collaboratori di Carlomagno nel campo della pubblica istruzione; con loro
terminava la conoscenza delle lettere greche in Occidente.
Gli ellenisti che si trovavano in Italia a partire
dal IX secolo, erano coloro che si recavano ad apprendere il greco a
Costantinopoli, con lo scopo, si pu� dire, di sevire il papa come ambasciatori,
per riportare gli scismatici nel seno della Chiesa romana o per tradurre in
latino le opere ecclesiastiche.
Tali erano Anastasio il Bibliotecario (IXmo sec.), Giovanni di
Napoli (Xmo sec.), Domenico Marengo (XImo sec.), Pietro Grossolano, Mos� di Bergamo, Leone Eterario e Burgundio di Pisa (XIImo sec.), Bonaccorso da Bologna e Nicola di �Otranto
(XIImo sec.), e molti altri sui quali si trovavano menzioni insignificanti
sparse in diverse opere (*).
Nel numero, sono appena compresi Papias, un
lessicografo lombardo dell�XImo secolo, che citava dei passaggi greci nel suo Ditionario, e, tra gli altri, dei versi
di Esiodo: Jacobus Clericus o Jacopo da Venezia,
veneziano che aveva tradotto
qualche libro di Aristotele. Bartolomeo di Messina che aveva tradotto le �Morali� di Aristotele, per ordine di Manfredi, re di Napoli e aveva
mandato questa traduzione all�universit� di Parigi; Giovanni d�Otranto che aveva celebrato
in versi greci l�assedio di Parma dell�imperatore Federico II; Guido dalla Colonna, giudice
di Messina, che aveva compossto, nel 1270, un�opera sulla guerra di Troia, per
la quale egli dovette servirsi di Omero, di Dares e dei Detti di Creta. �
Tra gli ellenisti italiani del medioevo, si
possono elencare Costantino l�Africano, nato a Cartagine, ritenuto a torto, fondatore
della Scuola di Salerno. Aveva fatto dei lunghi viaggi in Asia Minore e in
India; accusato di magia, fuggiva (1060) a Salerno, dove fu accolto dal duca
normanno Roberto il Guiscardo; mor� a Monte-Cassino con l�abito religioso di
quei frati. Aveva tradotto un gran numero di opere di medicina. Tiraboschi
assicurava che queste versioni erano state fatte su originali greci, mentre Daremberg
riteneva che Costantino Africano fosse un plagiaro in quanto le sue traduzioni sarebbero
state riprese da traduzioni arabe.
La vera Rinascenza dell�ellenismo aveva inizio
in Italia nel XIV.mo secolo; il problema della conciliazione delle due Chiese� (V. in Schede S. Il Filioque ecc.), era stato pi� agitato che mai; gli imperatori di
Costantinopoli, continuamente minacciati dai turchi,� avevano rivolto i loro occhi verso Occidente,
con la speranza di trovare� la loro salvezza.
La Chiesa latina, sensibile a queste richieste e sentendo il bisogno di avere
dei negoziatori versati nella conoscenza del greco, con il Concilio di Vienna
(1311), dispose che questa lingua fosse insegnata in diverse citt� d�Italia; �si trattava, � vero, della lingua volgare, ma
essa preparava alla conoscenza della lingua letteraria.
Il gusto letterario� della Corte di Provenza era penetrato nel
mezzogiorno d�Italia con la Casa d�Angi�; il re Roberto faceva di tutto per
propagare nei suoi Stati la conoscenza delle opere greche; egli aveva fatto
acquistare dei manoscritti di tutti i generi, affidando la traduzione agli
studiosi che dovevano tradurre in latino opere di legisti o medici greci. E�
per suo ordine che Nicol� Ruberto, vescovo di Reggio, aveva tradotto opere
filosofiche di Aristotele, il cui manoscritto � conservato nella Biblioteca di
Francia.
Il bibliotecario di questo sovrano fu Bernard Barlaam, precursore
della restaurazione dell�ellenismo in Italia e primo maestro di Petrarca. Era
monaco a Seminara in Calabria e si era recato a Costantinopoli per imparare il
greco;� si era legato all�imperatore
Andronico il Giovane, che gli affidava la missione della riunione delle due
Chiese, senza ottenere successo, per l�ostracismo oppostogli dagli
ecclesiastici greci, per cui dovette tornarsene in Calabria, dove fu nominato
vescovo di Geraci poi di Locri.
Durante la sua missione presso il papa ad
Avignone, conobbe Petrarca al quale insegn� i primi elementi della lingua
greca. Quando era in Grecia aveva scritto un trattato contro la supremazia del
papa, che fu stampato a Oxford nel 1592; aveva lasciato un�opera matematica �Logistik�s�, stampata a Strasburgo nel
1572; delle arringhe, delle lettere controverse ed altro. Il suo pi� grande merito
era stato quello di essere stato maestro del suo compatriota Leonzio Pilato, protettore di Petrarca e Boccaccio, da
considerare il primo ad iniziare gli studi di greco in Occidente e
primo traduttore di Omero.
Aveva appreso la lingua greca, vivendo per lungo
tempo in Grecia; Petrarca lo aveva conosciuto a Padova e gli aveva espresso il
desiderio di avere una traduzione di Omero. Boccaccio, venutone a conoscenza,
ne fu entusiasta e a sua richiesta il senato di Firenze nel 1360 aveva creato
una cattedra di greco, che fu la prima non solo in Italia, ma in tutto
l�Occidente. Boccaccio, preso da entusiasmo, non solo lo ospit� nella sua casa,
ma procur� in gran fretta un Omero e un numero considerevole di altri
manoscritti greci.
Accanto a
costoro, troviamo Pietro D�Abano (v. in Specchio dell�Epoca, La scuola di Padova) celebre alchimista
(morto verso il 1320) che aveva studiato a Costantinopoli e tradotto �Expositio problematum� di Aristotele
(Mantova 1475), �De medicorum astrologia�
di Ippocrate� (Venezia 1485)� e �Tractatus
varii di Galeno� (mns. a San
Marco, Venezia).
Gli eruditi
ci hanno conservato i nomi di due contemporanei di Leonzio Pilato, che erano
penetrati nel cuore della letteratura greca:
Rinaldo Persichelli
di
Cremona, morto
nel 1370, che aveva tradotto Pindaro in versi latini; �e il celebre canonista Pietro Bracco di Piacenza
, traduttore in latino di arringhe di Demostene e qualche �dialogo di Luciano, versioni andate perdute.
Il
principale centro del movimento letterario dell�ellenismo in Italia fu, nel XIV.mo
secolo, la citt� di Firenze e la sua anima era stata Palla Strozzi (1372-1562).
Poco
portato a ricercare onori pubblici, non dedito che a soddifare gli stimoli
intellettuali, non avendo altre ambizioni che quella di illustrare la sua citt�
natale, Strozzi aveva impiegato le sue grandi ricchezze per la diffusione delle
lettere. Fu grazie a lui che il celebre
Emanuele Crisolora
and� a rilevare a Firenze (1396) la cattedra
di greco, lasciata da Leonzio Pilato, il vero fondatore dell�ellenismo in tutto l��Occidente; il
fratello Giovanni Crisolora che, come
detto insegnava belle-lettere a Roma, aveva composto la prima grammatica greca Єροτήματα
�(Erotemata),
stampata a Venezia nel 1484� e
successivamente.
Palla
Strozzi non limit� le sue aspirazioni all�ardore per le lettere greche; egli
fece venire da Costantinopoli un gran numero di manoscritti greci: Platone,
Plutarco, la Politica di Aristotele,
la� Cosmografia
di Tolomeo ecc., e ne fece trascrivere altre. L�Universit� di Firenze che lo
pose� alla propria testa, a lui doveva
tutta la fama che essa aveva� raggiunto
in quest�epoca. Questi trionfi, conc�ude Firmin-Didot, impedivano il sonno a
Cosimo de� Medici, che aspirava al titolo di Mec�ne, e quando raggiunse il
potere, si premur� di esiliare il rivale, per cui Strozzi� si rec� a Padova e con l�aiuto di Argiropulo,
tradusse diverse opere greche.�
*)
Gradenigo, Raggionamento istorico-critico
alla letteratura greco-italiana (Brescia 1759); Sch�ll, Histoire de la litterature greque profane
t, VII, e G. Faure in M�lange d�histoire
litteraire, R�sum� chronologique.
LA SCUOLA
DI
EMANUELE CRISOLORA
E I SUOI ALLIEVI
A FIRENZE�
(Alcuni degli ellenisti menzionati, in parte, �
integrano quelli indicati tra i pre-umanisti
nel cit. art. Carlo V ecc., P. I �Sez. I)
|
D |
alla Scuola
di Emanuele Crisolora, scrive Firmin-Didot, usciva tutta una schiera di giovani
ellenisti che facevano onore al loro maestro e alla loro patria; essi avevano
compreso che per estendere con successo l�insegnamento del greco, sarebbe
occorso svegliare la curiosit� e formare il gusto del pubblico alla letteratura
ellenica, e la via della traslazione sarebbe stata pi� pronta, e si misero quindi
con ardore a tradurre gli autori greci. �
Battista Guarini di Verona, uno dei migliori allievi di Crisolora e suo
successore nella cattedra di greco a Firenze; �dopo aver insegnato a Venezia e Verona,
tradusse Strabone, su richiesta del papa Nicola V (v. Art. Carlo V ecc, P.I L�Umanesimo).
Alla sua morte, avvenuta nel 1460, dicono, si fosse fermato al libro X; la continu�
Gregorio Tiferna
(Roma verso il 1470 � Venezia 1472 in.fol.); Guarini tradusse anche Plutarco, �Della educatione del fanciullo�,
stampato intorno al 1470, e le �Vite
degli uomini illustri� (Brescia 1488).
Leonardo Bruni, detto l�Aretino, altro allievo di Crisolora,
tradusse Ariosto, l� �Etica�
(Strasburgo verso il 1470; Roma 1473 ecc.), qualche discorso di Eschine e �Della Prima guerra punica� di Polibio
(Brescia 1498).
Un uomo, al
quale l�ellenismo di Firenze doveva molto, fu Niccol� Niccoli (1363-1437), colto discepolo di Crisolora; ardente
ricercatore di manoscritti che egli stesso copiava e sebbene non avesse niente
scritto e niente tradotto dal greco, lo si pu� considerare come il prosecutore
della crititca filologica. La sagacia che aveva impiegato a correggere gli
errori dei manoscritti � semplicemente meravigliosa. E� a Niccoli che si deve
essere debitori� di un cambiamento
radicale nella educazione dei giovani e il legato che egli fece di ottocento
manoscritti, fu il punto di partenza della Biblioteca Riccardiana di Firenze
(allocata nel Palazzo Medici-Riccardi).
Nelle
ricerche egli fu accompagnato da un suo vecchio condiscepolo, Ambrogio Traversari, detto il Camaldolo, eminente teologo,
versatissimo nella lingua greca, traduttore di Diogene Laerzio (Venezia 1475).
Racontava che a Mantova aveva trovato dei ragazzi che conoscevano il greco,
indicando nel numero, la figlia del marchese di Mantova di otto anni. Il Camaldolo (morto nel 1439), aveva
appreso il greco a Venezia da Crisolora e non fu per insegnarlo. Egli
rappresent� il papa al Concilio di Firenze dove discett� alla presenza del
clero e dell�imperatore greco, nella loro lingua. Fu lui a redigere in latino e
greco il patto della unione delle due Chiese. Tradusse un gran numero di opere
di teologia, di san Efrem, sant�Anastasio, san Basilio, san Giovanni Crisostomo
e altri.
Ognibono da Lonigo (Omnibono Leoniceno), altro allievo di
Crisolora e in seguito insegnante di belle lettere a Venezia; aveva tradotto
qualche favola di Esopo e il trattato di Senofonte Sulla Caccia, versioni inedite. Suo parente e discepolo, Nicola Leoniceno
(1428-1524), medico di grande autorit�, aveva trattato diverse volte questioni
del suo genere e traduzionI di opere della sua specialit�, come una parte di
Galieno e Gli animali di Aristotele;
aveva tradotto anche la� Storia� di
Dione Cassio e i �Dialoghi� di
Luciano, ma nessuna di tali opere era stata pubblicata.
Giacomo D�Angelo, altro allievo di Crisolora, aveva tradotto
diverse biografie di Plutarco, rimaste inedite e la �Cosmografia� di Tolomeo (Bologna 1472; Vicenza 1475; Roma 1478; Ulma
1482).
Un posto
paricolare nella storia della Rinascenza, appartiene al fiorentino Giannozzo Manetti
(1396-1459) che nella sua giovinezza aveva probabilmente seguito il corso di
greco di Crisolora. Ardente per lo studio, pervicace nel lavoro, scrive
Firmin-Didot, divenne uno dei pi� forti ellenisti del suo tempo e uno dei pi�
colti nell�accezione generale del termine, al punto che Tiraboschi non esita ad
affermare che si trovano pochi eguali a Manetti, nella storia di tutti i
secoli.
Perseguitato
nella sua patria, si era rifugiato a Roma, dove il papa Nicola V, illustre
collezionista di manoscritti, lo nomin� suo segretario. Non aveva potuto
scegliere di meglio, perch� Manetti era bibliofilo infaticabile che giunse a
riunire una biblioteca nutrita e rimarcabile, con l�intenzione di renderla
pubblica, ma and� dispersa dopo la sua morte. Di lui non si conosce alcuna traduzione
personale di alcun autore greco, sebbene avesse potuto offrire l�appoggio del
suo grande sapere, ai traduttori impiegati�
presso Alfonso il Grande, re di Napoli.
Altro
bibliotecario di Nicola V, Giovanni Tortelli di Arezzo, amico di Lorenzo Valla; aveva
tradotto qualche vita di Plutarco (edizione di Roma 1470 in-fol.).
Non si pu�
omettere Pier-Paolo Vergerio il
vecchio. nato verso il 1339 e morto nel 1420; aveva cominciato ad apprendere
il greco in et� avanzata a Firenze, probabilmente sotto Crisolora ed ebbe l�onore
di essere il primo traduttore di un libro di greco al tempo della Rinascenza.
Al servizio
dell�imperatore Sigismondo, per suo ordine, dopo il 1410, fece una versione di
Arriano in un latino puro ed elegante; essa non fu mai stampata e i manoscritti
sono tanto rari al punto che Hallam, riferiva:- �Dicono che uno si trova� nella
Bibioteca Vaticana; ma, aggiungeva, �
molto poco conosciuto�. Provo un certo piacere, (scrive Firmin-Didot), far
sapere che possiedo un superbo manoscritto su velina, eseguito in Italia nel quindicesimo secolo.
Uno dei pi�
grandi ellenisti italiani � stato Carlo Marsuppini, detto l�Aretino, nato ad Arezzo (1399-1453);
a lui si deve la traduzione in esametri della �Batracomiomachia� (*) (Parma 1492, Modena 1498 ecc.) e la versione
del �Dialogo� di Luciano �Della virt��. Francesco Fidelfo ebbe un
ruolo considerevole nelle lettere; aveva soggiornato a Costantinopoli
(1420-27), dove aveva appreso il greco da Giovanni Crisolora. Sposato con la
figlia di Fidelfo, venne in Italia a insegnare il greco a Venezia nel 1428 e
nel 1429 occup� la cattedra di letteratura greca e latina a Firenze, senza
dubbio rimpiazzando Aurispa. Dotato di intelligenza brillante e di un ardore
infaticabile per lo studio, raggiunse la fama di essere il maggior conoscitore
della lingua greca che vi fosse in Occidente. Tradusse diverse opere di
Aristotele, Senofonte, Ipppocrate, Plutarco ed altri. Suo antagonista fu Poggio Bracciolini che si era
consacrato alla letteratura latina lasciando una traduzione di Diodoro Siculo
(Bologna 1472, Venezia 1476 e 1481, ecc.). Giovanni Aurispa (morto il 1459), siciliano
di nascita; da un suo viaggio in Oriente port� trentadue manoscritti;� insegn� greco a Firenze e Ferrara dopo il
1433 e tradusse il trattato di Ierocle di Alessandria, sui �Versi dorati� di Pitagora, e un
frammento di Dione Cassio.
L�avvenimento
dei Medici al governo della repubblica, dava alle lettere nuova fama: Cosimo de� Medici
(1434-1464), emulo di Palla Strozzi, ardente protettore dell�ellenismo, segu�
il suo esempio geniale. Soprannominato il Pericle di Firenze, accolse con
favore Giovanni Argiropulo, giunto da Costantinopoli il 1434 e lo nomin�
insegnante di greco del figlio e del nipote.
Argiropulo
fece una fedele traduzione della �Morale�
e della �Politica� di Aristotele,
pubblicate dopo la sua morte (1473), a Firenze nel 1487, con i commentari di
uno dei suoi allievi, Donato Acciaiuoli (1428-1478), antico confaloniere della
repubblica, traduttore egli stesso di diverse �Vite� di Plutarco, pubblicate a Firenze nel 1478. Argiropulo, dopo
aver professato il greco a Firenze, si era recato a Roma (1470) dove tenne un
corso di letteratura greca. Altro allievo di Argiropulo, Alamanno Rinuccini
(1420-1504), fiorentino, aveva pubblicato una traduzione di Plutarco, �La virt� delle donne� (Brescia 1465) e
tradusse, di Filostrato,� �La vita di Apollonio di Tirana� (ritenuto
il Ges� laico, con fonti documentate, del II secolo). Nei primi
anni di� regno di Cosimo de� Medici, il
celebre neoplatonico Gemisto Pletone �era
giunto, in occasione del prossimo Concilio di Firenze (1438), soggiorando a
Firenze dove si intrattenne su Platone (**). �
Il grande
Giacomo Leopardi (***), che fu ellenista rimarchevole dei tempi pi� vicini a
noi, riteneva Pletone uno dei maggiori geni e pi� distinti del� suo tempo. Per i suoi lavori e per ci� che
avevano provocato le� sue dottrine, egli,
scrive Firmin-Didot, �ebbe una potente
influenza sul progresso dell�ellenismo in Italia, in quanto aveva fatto meglio
conoscere le opere dei due grandi filosofi dell�antichit�. Cosimo si entusiasm�
per le sue teorie platoniche sulla teologia naturale e decise di fondare
un�Accademia speciale per propagare le sue dottrine.
Fu scelto
un giovane dotato di viva intelligenza per divenire un giorno, capo di questa
propaganda: era Marsilio Ficino, all�et� di ventitre anni (1456) cominci� ad
apprendere il greco. Da quanto riferisce Bartolomeo de� Sacchi, detto Platina,
debutt� con una traduzione di Mercurio Trismegisto (v. in Schede F. Il Libro di Tot tra Libro dei tarocchi e
Corpus Hermeticum), del libro �Della
potenza e saggezza di Dio� (Treviso 1471, Ferrara 1472, Venezia 1481,83,
91, 93) che ebbe un gran successo. Nel 1453 tradusse in latino le opere di
Platone che furono pubblicate nel 1483-84 a Firenze; le opere di Plotino
apparvero in seguito (1494).
Simultaneamente
a Firenze, un altro centro di attivit� letteraria sorto in Italia fu quello di
Napoli, sotto il geverno del saggio e illuminato Alfonso V D�Aragona (1396-1458).
Questo monarca molto colto, attir� alla sua Corte un gran numero di studiosi;
sovrano magnanimo, fu il loro benefattore; i posteri, consacrando i suoi
meriti, gli attribuirono il titolo di Grande; egli fece enormi sacrifici per la cultura
delle lettere e prendendo come segretario Manetti, lo rassicur� che avrebbe
diviso con lui il suo ultimo pezzo di pane. Una parte della sua bella
biblioteca fu portata a Parigi, dopo la conquista di Napoli da parte di Carlo
VIII; si trovano ancora, scrive Firmin-Didot, nella nostra Bibliotea di
Francia, bei manoscritti di tale provenienza, con le armi di Napoli o altre,
impresse sulla rilegatura; il re Alfonso aveva preso per emblema un libro
aperto.� Lorenzzo Valla (1406-1457) abile ellenista che aveva appreso il greco
all�et� di trentasette anni dal siciliano Govanni Aurispa (1376-14599
il quale si era recato a offrire i suoi servigi ad Alfonso di Napoli. che lo
nomin� suo segretario, con l�incarico di tradurre degli autori greci; Valla
apr� allora una scuola di eloquenza greca e latina che ebbe breve durata. Si
rec� a Roma dal papa Nicola V per offrirgli la prima traduzione latina di
Omero, dopo Leonzio Pilato, che non era ancora conosciuta.� Dopo aver fatto una versione di Tucidide che gli
fu ricompensata con cinquecento scudi d�oro e altri vantaggi, ritorn� �a Napoli dove mor�. Le sue versioni
dell�Iliade di Omero, in prosa, di Erodoto e di Esopo, non furono pubblicate
che dopo la sua morte;� Omero (a Brescia,
8 dic. 1474), Erodoto (a Venezia, 1474, a Roma 1475 e Venezia 1494), Esopo (?
1488).
Niccol� Della Valle (c.ca: 1451-1473), mor� a ventidue anni; tradusse
in versi latini i libri 3,4,5.13.18.20. 22.23 e 24 dell�Iliade di Omero (Roma febbr. 1474), e di� Esiodo, e le �Opere e i giorni�.� Bartolomeo Fazio morto alla
Corte di Napoli nel 1457; di Arriano, aveva
tradotto �Le conquiste di Alessandro� (De
rebus gestis Alexandri), Pisa 1508.
Pietro Candido,
aveva dedicato al re Alfonso V le
sue traduzioni di una parte di Arriano (Venezia 1472,1477, 1492; Reggio 1494,
Scandiano 1495). �Lelio Castellano, scrisse una
versione di Luciano con questo titolo: �De
veris narrationibus� (Napoli 1475). Gregorio Tiferna, rientra nel numero degli insegnanti di greco
a Napoli ma anche a Milano e Roma; nel 1455 ottenne la prima cattedra di greco
a Parigi, ma in capo a quattro anni torn� a Venezia dove rimase fino alla morte
(1466). Aveva tradotto sette libri di Strabone e un trattato di Dione
Crisostomo.
Venezia non
era stata l�unica a introdurre lo studio del greco; dall�inizio del XIVmo
secolo, seppe attirare Crisolora che vi insegn� per quattro anni. A Filelfo era
succeduto Giorgio di Trebisonda che il patrizio Francesco Barbaro lo aveva
fatto venire dalla Grecia (verso il 1428), per rimpiazzare Fidelfo nella
cattedra di greco a Venezia; ma vi rimase qualche anno, recandosi poi a Roma.
Aveva cessato di insegnare nel 1450, dedicandosi alla traduzione di un numero
considerevole di autori greci, ma in una maniera sciatta; mor� nel 1486.
Man mano
che le armi vittoriose ottomane soggiogavano la Grecia, cocnlude Firmin-Didot,
un numero di studiosi greci venivano a cercare ospitalit� in Italia ed era
sopratutto a Venezia che di preferenza si fermavano.
*) �La battaglia dei topi e delle rane�, � come
un racconto di Esopo; � un racconto burlesco, attribuito ad Omero; composto
probabilmente fra il VI e il IV sec., e fu per lungo tempo testo scolastico;
piacque molto ad antichi e moderni e Leopardi la tradusse pi� volte e lo
complet� con i �Paralipomeni della Batracomiomachia� (Cronache della
Batracomiomachia).
�**) V. in Schede filosofiche: Polemiche umanistiche tra platonici e
aristotelici; La polemica continua;� I
primordi dell�averroismo e la Scuola aristotelica-averroistica di Padova, P.I,
II.
***) Questo
nome affascinante, ci fa saltare sulla sedia tutte le volte che ci compare
davani agli occhi; il titolo di �grande�
che gli spetta che� una volta era dato a
personaggi di questo livello, ora, per la rivoluzione fatta da facebook, � divenuto di uso tanto comune
che � dato a� tutte le mezzecalzette! Leopardi lo abbiamo gi� indicato in riferimento
a Pletome (Art.cit.); ma la curiosit� ci ha spinti a rifare la ricerca e questa
volta, siamo rimasti ancora pi� sbalorditi sulla profondit� della sua conoscenza
delle lingue antiche (conosceva anche l�ebraico), fino al punto di rilevare
diversit� minime. In Zibalddone (al
n. 997), parlando delle differenze della lingua greca classica e della lingua
latina, dice di preferire la lingua greca
che egli trova meno complessa, e aggiunge: nella lingua greca fino agli ultimissimi tempi dell�impero greco, si
trova persino una certa eleganza di lingua e di stile. E prosegue: In Gemisto � meravigliosa l�una e l�altra.
Tolti alcuni piccoli erroruzzi di lingua (non tali che siano manifesti se non
ai dottissimi); le sue opere o molte di esse, si possono sicuramente paragonare
e mettere con quanto di pi� bello ha la pi� classica letteratura greca e il suo
miglior secolo. Da rimanere sotto chok!�
L�ELLENISMO
NELLE �PICCOLE
�CORTI DI FERRARA ��
MANTOVA E URBINO
L� ELEZIONE DEL
PAPA
�NICOLA V
|
U |
n piccolo
Stato segu� subito questo movimento generale verso gli studi dell�antichit� e
fu il marchesato, poi ducato di Ferrara. L�Univesit� era stata inaugurata nel
1402 con l�interessamento del marchese Nicola III d�Este che ne fondava
un�altra a Parma. Nonostante il periodo delle guerre, le lettere antiche
prendevano radici, grazie allo studioso ellenista Giovanni Aurispa e al celebre
Battista Guarini che insegnava a Ferrara. Il Concilio che ebbe luogo a Ferrara
nel 1438 durante il governatorato di Nicola III, vide dei grandi personaggi e
illustri studiosi dell�Oriente greco, assistendo alle loro riunioni private e
alle discussioni filosofiche tche avevano luogo tra grecci e latini.
Lionello
d�Este, figlio naturale e successore di Nicola III, prosegu� l�opera
civilizzatrice di suo padre, con maggior impegno, in tempi pi� tranquilli.
Brillante allievo di Guarini, Lionello, votato con ardore alle lettere,
contribu�, scrive Sismondi, pi� di ogni altro principe, a dare alla letteratura
antica l� impulso che ha distinto il XVmo secolo� in una maniera cos� brillante.
Borso
d�Este, primo duca di Ferrara, Modena e Reggio, altro figlio naturale di Nicola
III e successore di Lionello, fu non meno devoto protettore delle lettere; i
contemporanei non risparmiano gli elogi sulle sue liberalit� nei confronti
degli sudiosi. �
Poco prima
della sua morte egli introdusse a Ferrara la stamperia nascente che Andrea
Beaufort, dice Andrea Gallicus o di Francia, stabil� per primo, Dopo questo
momento, la fama di Ferrara � legata a quella delle lettere. Ercole I d�Este
(1433-1505), figlio legittimo di Nicola III e successore di Borso, continu� la
tradizione della sua famiglia e attir� alla sua Corte i poeti e letterati pi�
rinomati. Ariosto fu suo commensale ed � a Ferrara che fu stampata nel 1516, la
prima� edizione del celebre poema dell�Orlando furioso.
Il figlio
maggiore di Ercole I, fu Alfonso I, marito di Lucrezia Borgia; sorella di
Alfonso era Isabella d�Este, natura
d�elite, di spirito coltivato e appassionato per le arti e per le lettere; con
lei la Corte di Ferrara divenne un centro di lumi, dove i malori di Tasso ne accrebbero la celebrit�.
Ferrara fu
seguita da Mantova dove il primo marchese Giovan-Francesco I Gonzaga aveva
avuto la saggezza e la fortuna di legarsi al celebre studioso Vittorino �Rambaldoni detto Vittorino di Feltre� (1379-1447).
A una vasta istruzione egli univa� le pi�
preziose qualit� di cuore. �E� una
sorpresa�, scriveva Ginguen�, �trovare
in un secolo ove vi era ancora della rozzezza nei costumi, un modello cos�
perfetto di educazione letteraria e civile�. Il marchese di Mantova lo
aveva chiamato da Venezia, dove Vittorino dirigeva con successo una scuola
pubblica, al fine di affidargli l�educazione dei ragazzi.
Nelle sue
nuove funzioni, si era dedicato non pi� al ruolo di insegnante privato, ma, con
l�autorizzazione del marchese, ammetteva altri allievi alle sue lezioni, La sua
celebrit� fu tale, che accorrevano dalla Francia, Germania, e dalla stessa
Grecia e la scuola di Mantova si mise al livello delle altre pi� illustri
Universit�.
Tutti i
suoi allievi, fecero onore al loro maestro: Il figlio maggiore del marchese ,
Luigi III Gonzaga, aggiunse ai suoi talenti militari, il gusto per le lettere e
le arti; ma, tra tutti, si distinse la sorella di Giovan-Francesco, Cecilia Gonzaga (1426-1451) da mettere
tra i pi� virtuosi e colti personaggi del XIVmo secolo. Ambrogio di Camaldoli,
riferisce che all�et� di otto anni, conosceva il greco e giunse a scrivere con
gran purezza.
La nipote, Barbara Gonzaga (1455-1503), figlia di Luigi III, occupa un bel posto nella
storia delle lettere. Sposata al duca di W�rtemberg, fu
lei ad essere la fondatrice dellUniversit� di Tubinga (1477), prodigando
incoraggiamenti ai personaggi di cultura, tra i quali, il celebre Johan Reuchlin,
fondatore degli studi greci in Germania.
La
rinascita delle lettere a Roma non data che dall�elezione del papa Nicola V (v. Art.
cit,), nel 1447: dopo la sua elezione era dominato dalla cura
delle lettere, piuttosto che� seguire le
lotte intestine che in quel periodo travolgevano l�Italia, assumendo per i suoi
Stati, una posizione neutrale e pacifica al fine di concentrare tutte le
risorse finanziarie all�abbellimento della citt� e all�acquisto di manoscritti
che faceva abbellire con rilegature e miniature. Sotto i suoi auspici si
distinsero Aurispa, Manetti, Tiferna e particolarmente Trebisonda e Teodoro
Gaza che tradussero Tucidide, Diodoro Siculo, Appiamo, Polibio, Strabone e una
parte di Aristotele e Platone: Perfino sul letto di morte aveva espresso il
desiderio di far tradurre Omero in esametri.
Lo studio
della lingua greca a Roma, era stato trascurato fino all�arrivo di Bessarione (v.
Art. cit) giunto nel 1439; il quale ricercava bei manoscritti da diventare
antagonista di �Nicola V, che lo trattava
con freddezza, anche a causa della nomina di Bessarione a papa, nomina revocata
dallo stesso collegio di cardinali che lo aveva votato (v. cit. Art.). Bessarione
si mise quindi a tradurre Senofonte, Aristotele, Teofrasto e altri; alla sua
morte lasci� tutti i suoi manoscritti al Senato di Venezia che costituirono il primo
fondo della Marciana e servirono ad Aldo per le sue pubblicazioni.
Bessarione
era stato seguito da Crisolora e Gregorio Triferna, e infine da Argiropulo dopo
il 1470.
I mecenati
dell�ellenismo che non bisogna dimenticare, scrive Firmin-Didot, sono Federico da Montefeltro,
duca di Urbino (1410-1482), allievo di Vittorino da Feltre. Molte traduzioni
dal greco furono eseguite per lui; egli che era uno dei pi� grandi capitani del
suo tempo, aveva mescolato le preoccupazioni letterarie alla sua attivit�
guerriera. Cos�, alla presa di Volterra, durante il saccheggio generale prese
come propria parte, una magnifica bibbia in ebraico. Dopo la sua morte, la sua
passioe di bibliofilo rese un segnalato servizio alle lettere greche, in quanto,
nella sua magnifica biblioteca,� nel 1515
furono scoperte due nuove commedie di Aristofane: Lisistrata e Tesmoforiazuse
(Le donne alle Tesmoforie).
La rovina
definitiva della indipendenza della Grecia (1453) ebbe per effetto di fare
dell�Italia la sede dell�ellenismo e gli studi greci fecero rapidi progressi.
Come
ulteriori ellenisti italiani, prima di Aldo Manuzio, sono da ricordare Pietro Balbo di Pisa,
morto nel 1479, traduttore di �Alcynoi
Epitome in disciplina Platonis� (Roma 1469) oltre a qualche ecclesiastico
greco. Lapo Birago, fiorentino, allievo di Fidelfo e pi� tardi
insegnante a Bologna, traduttore di diverse �Vite� di Plutarco (Venezia, Janson 1478) e Dionigi di Alicarnasso (Treviso
1478); Bonino Mombrizio, milanese,
(1424-v.1482), traduttore di �Teogonia�
di Esiodo in versi esametri latini (Ferrara 1474), Nicola Perotti,
traduttore dei primi cinque libri di Polibio (Roma 1473); Filippo Veneto,
traduttore della �Fisica� e �Metafisica� di Aristotele (Venezia
1482); Stefano di Messina (Messanensis), traduttore di Hermetis
Trismegisti Centiloquium (Venezia 1492) Raffaele di Volterra, traduttore dell�Odissea di Omero (Brescia
1497); Francesco Rinucci di Arezzo. traduttore dei �Dialoghi� �di Luciano (Roma
v. 1470), �De Plutarchi Apophtegmata�
(Venezia 1470) e �De Phalaridis
epistolae� (Roma v. 1470 e altre numerose edizioni fino al 1510).
Cos�, come
si � visto, in molte citt� italiane vi erano cattedre di lingua e letteratura
greca prima del XVmo secolo: a Firenze avevano insegnato, dopo �Crisolora (1396-1402), Guarini (1415) Aurispa
e infine Filelfo (1429); a Venezia, Crisolora (1402-1406), Omnibono Leoniceno,
Guarini (1415-22), Filelfo (1428-29), Giorgio di Trebisonda fino al 1450.
Tifernas (1460-1466); a Verona, Guarini (1422-1436); a Ferrara: Aurispa (dopo
il 1433), Guarini� (1436-60) e Teodoro Gaza,
che aveva insegnato greco al ginnasio di questa citt� (1441-1450),
Le altre
citt� come Milano, Pavia, Roma, Napoli non ebbero insegnanti che a intervalli e
la loro storia � tutta da scrivere. Bologna dove regnavano gli studi giuridici,
aveva accolto con freddezza la istituzione di un corso �di greco con Aurispa.
Questo
era lo stato degli studi prima che Aldo Manuzio entrasse in scena; solo quattro
autori greci erano stampati in originale. Esopo, Teocrito, Omero e Isocrate;
tutte le altre opere erano conosciute in lingua latina pi� o meno fedele.
Il
pubblico era stato preso dall�immenso ardore per l�ellenismo: non bastava pi�
conoscere gli autori greci con gli occhi dei traduttori; essi desideravano
avere subito la conoscenza del personaggio sotto una forma affabile, se non
denaturata; volevano che si �sollevasse
il velo che� nascondeva la bellezza della
forma in originale; volevano avere la gioia che procura la contemplazione� di un capolavoro. �Dateci dei testi greci� era il grido generale.
Questi
testi greci stampati, non esistevano, Le stesse traduzioni latine� che non consistevano principalmente che in
opere di filosofia, morale, storia, non avevano ancora offerto che una
ristretta porzione di letteratura greca. I grandi autori drammatici, Eschilo,
Sofocle, Euripide, Aristofane erano ancora sconosciuti ed era l� che
principalmente era testimoniata la sublimit� incomparabile del genio greco.
Occorreva un uomo, superiormente dotato, per soddisfare il voto del pubblico: e
quest�uomo era Aldo Manuzio.
�
A CHE PUNTO ERANO�
GLI STUDI DEL
GRECO�
QUANDO ALDO
INIZIAVA
LA SUA ATTIVITA�
|
I |
l nome Aldo, era abbreviazione di Teobaldo,
donde Aldus Manutius Bassianus Latinus; era
nato negli Stati romani a Bassiano-Sermoneta tra il 1449/50, da famiglia da
lungo tempo latina. Essendosi occupato della educazione di Alberto Pio, figlio
maggiore dei principi di Carpi, con la protezione di questa faniglia aveva
avuto il permesso di aggiungere il nome �Pio�
al proprio, e (dal 1503) si designava come Aldus
Pius Manutius Romanus.
Per i suoi
studi aveva avuto un pedagogo pedante, che gli aveva �insegnato la Grammatica ritmica di Alessandro
Villa-Dio, l�unica allora in uso, che Aldo aveva �preso in tale antipatia, che pi� tardi ne
compose una (Rudimenta Gramatices lingu� �latin�, 1501)
che ebbe grande successo in Italia e all�estero.
Dopo aver
terminato gli studi a Roma con abili maestri, si era recato a Ferrara per
seguire le lezioni di greco di Battista Guarini, al quale, nella prefazione che
gli aveva dedicato nel testo di Teocrtito
del 1495, gli aveva dimostrato la sua riconoscenza.
Aldo, volendo
trasmettere il gusto per le lettere, a Ferrara aveva intrapreso a leggere e
spiegare pubblicamente i migliori scrittori greci e latini; aveva tenuto questo
suo corso �per diversi anni, e i giovani
che lo seguivano erano numerosi e tra costoro vi era Ercole Strozzi, per il
quale pi� tardi aveva stampato le poesie e composto l�epitaffio in versi
latini.
Durante la
guerra del duca di Ferrara Ercole d�Este con Venezia, Aldo lasci� Ferrara
(1482) e si ritir� a Mirandola presso Giovanni Pio, suo condiscepolo a Ferrara,
dove� fu suo ospite per due anni. Per
mezzo di Pico della Mirandola, Aldo, si leg� in amicizia con Emanuele
Adramittenos di Creta, con il quale approfond� la conoscenza della lingua e dei
monumenti letterari greci; e quando la patria del suo amico era stata� conquistata dai turchi, era stato preso da
tanto dispiacere, da assumere il titolo di �filelleno�
che si trova stampato nei suoi primi libri. Nulla
di pi� glorioso e pi� toccante, scrive Firmin-Didot, erano i sentimenti d�amore per le lettere, che univano le varie classi
della societ�, che costituivano una ideale Repubblica delle Lettere.
Aldo a
Mirandola curava l�educazione del figlio della sorella di Pico, Caterina Pia
(che dalla corrispondenza avuta con Aldo dimostrava di avere anch�essa conoscenza
del latino e del greco), il giovane principe di Carpi, Alberto Pio e suo
fratello Leonello; e Pico ebbe modo di apprezzare le qualit� di Aldo.
Per rendere
pi� gradevoli le sue lezioni e stimolare l�emulazione, Aldo ammetteva, per
prendervi parte, qualche giovane allievo che si era distinto per suoi meriti,
come ricordava un professore di Bologna (Jaques Beranger in Isagoges Anatomes su�)� nella dedica al principe Alberto di Carpi, in
cui egli parlava dei brillanti studi fatti con il benamato precettore Aldo Manuzio Romano.������ �
Era il periodo
della polemica tra aristotelici e platonici (v. Art. cit.) e le discussioni
avevano colpito Aldo che si mise a studiare la filosofia, e Pico gli aveva
scritto una lettera da Firenze dicendogli che la filosofica cerca la verit�, la teologia la trova, la religione la
applica. Queste parole, scrive Firmin-Didot, ci ricordano che Pico della
Mirandola, che fu amico di Marsilio Ficino, ammiratore e primo traduttore di
Platone, �tentava di avvicinare le
dottrine di Platone con quelle di Aristotele e di conciliare le deduzioni della
filosofia con la rivelazione della religione, tentativo ardito che senza il
rango elevato al quale apparteneva, lo esponeva alla persecuzione (infatti
fu arrestato dagli inquisitori, mentre si recava a Parigi nel 1488)� e,
credendo di trovare le fonti della saggezza umana negli studiosi orientali, era
caduto nelle fantasticherie mistiche della cabbala�.
Aldo seppe
preservarsi con la sua intelligenza da queste aberrazioni e dalle credenze dell�astrologia,
allora cos� comuni, come risulta da una sua lettera al duca di Urbino,
Guglielmo da Montefeltro, che credeva nell�influenza degli astri sul destino
umano. Ora (prosegue Firmin-Didot), vediamo a che punto fossero giunti gli
studi greci in Italia.������������������������������������
La
Greia, conquistata sui campi di battaglia, dominava gli spiriti dei
conquistatori con la lingua ricca e perfetta e la sua letteratura� cos� varia, originale e attraente.
La
civilizzazione greca, aveva lasciato tracce talmente profonde nel cuore
dell�impero romano, che, al momento della sua caduta, malgrado tutte le
vicissitudini politiche e nello stesso tempo delle invasioni barbariche,
l�Italia aveva conservato un ricordo tradizionale e una vaga ammirazione� per i tesori letterari della Grecia. Tanto
che sul resto dell�Europa si era appesantito il giogo del latino barbaro, unito
alle sottigliezze della scolastica e l�Italia non aveva completamente rotto la
catena che la univa alla Grecia, sebbene scismatica, e aveva preparato la via a
una resurrezione di un passato fecondo per l�avvenire.
Le
colonie greche marittime della Magna Grecia, avevano conservato per lungo tempo
il loro linguaggio originario. Fino al Xmo e XImo secolo le carte e documenti
ufficiali, scritti in greco, che si trovano negli archivi di Napoli e Sicilia,
attestano che l�impiego della lingua greca si manteneva ancora in quest�epoca,
nell�Italia meridionale.
Gli
italiani e principalmente le repubbliche di Genova e Venezia, possedevano delle
basi commerciali che risalivano al tempo dell�impero romano e i rapporti
costanti di queste colonie con la capitale fanno presumere che la conoscenza
del greco non era estranea ai commercianti d�Italia.
Al
Xmo secolo � fatta menzione di una discussionme grammaticale tra un
ecclesiastico di Novara di nome Gunzo, che citava il testo dell�Iliade e i
monaci di San Gallo. I monaci dell�ordine di san Basilio, numerosi in Italia,
soprattutto in Calabria, successivamente all�XImo secolo, usavano il greco come
lingua liturgica. E� dai loro ranghi che erano usciti i pi� ardenti promotori
della riconciliazione della Chiesa greca con quella latina e questa iniziativa
non contribu� poco alla propagazione del greco in Italia.
Abbiamo
visto che nel XIVmo secolo, Bernardo Barlaam di Seminara, dopo essere andato a
studiare il greco in Grecia, era stato incaricato delle trattative per la
riunione delle due Chiese, senza riuscire in questa impresa impossibile (v. in
Art, I Mille anni dell�impero bizantino ecc.);
egli sebbene avesse avuto poca influenza, si poteva considerare come� prosecutore della restaurazione degli studi
greci in Italia, per i suoi rapporti con Petrarca. Era stato seguito da
Emanuele Crisolora, da considerare il vero fondatore della rinascita
dell�ellenismo, non solo in Italia ma in tutto l�Occidente. Dopo di lui vi
erano stati, nel XVmo secolo, Ambrogio Traversari detto il Camaldolo, che
abbiamo trovato a Mantova e Battista Guarini che aveva insegnato il greco ad
Aldo Manuzio.
La
caduta dell�impero greco (1453) aveva avuto l�effetto di far venire in Italia
molti degli studiosi che erano rimasti in Grecia, che avevano portato con s� i
tesori dell�antichit� letteraria greca, diffondendo in molte citt�,
paricolarmnente a Venezia, l�insegnamento del greco; si vide allora, aveva
scritto Aldo, applicarsi fino ai
vegliardi, sull�esempio di Catone, allo studio del greco e la giovinezza e
l�infanzia coltivare ugualmente il latino.
L�avidit�
di procurare i testi greci fu tale che Aldo decise di dedicare la sua vita alla
loro pubblicazione. Questa passione per lo studio del greco, dall�Italia si
propag� in Germania, in Francia fino alla Pannonia, in Inghilterra e in Spagna.
��
Il
pi� grande ostacolo al progresso degli studi greci, come aveva constatato personalmente
Aldo, era la penuria di testi greci stampati fino a quel momento, in quanto i
manoscritti non potevano essere alla portata di tutti. Quali erano in effetti i
libri propagati in questa lingua dalla tipografia verso il 1490, epoca nella
quale Aldo� aveva messo in esecuzione il
suo grandioso progetto?
In
base alle ricerche fatte da Firnin-Didot, era risultato che l�Italia aveva
avuto l�onore di precedere tutti gli altri paesi; quattro citt� avevano
stampato dei libri greci, prima che Aldo, nel 1495 avesse anticipato tutte le
altre stamperie d�Europa: queste citt� erano innanzitutto Milano, seguita da
Venezia, Vicenza e Firenze.
A
gennaio del 1476,� era apparso a Milano
il primo libro stampato in greco, la Grammatica
di Lascaris, presso Paravicini (Impressum
per magistrum Dionysium Paravisinum); una volta uscito dalla stamperia del
Paravisini, la sua esecuzione per ci� che concerne la parte pi� importante,
vale a dire la stampa e la fonte dei caratteri, doveva essere attribuita a
Demetrio il Cretese (il commento fatto sulla esecuzione del lavoro era stato il
seguente:- In quest�opera il carattere � pressapoco
senza legature. gli accenti non sono separati ma fusi con le lettere; la
fusione � molto irregolare e alcune delle lettere iniziali, imitate da qualche
manoscritto, sono bizzarre).
Nelle
sue due prefazioni, una in greco, l�altra in latino, indirizzate �ai giovani che desiderano istruirsi�,
Demetrio esponeva che �per sopperire alla
mancanza di libri greci, fossero necessari i loro studi; e nella speranza di
soddisfare i loro voti, egli tentava di fare qualcosa degna di memoria,
sforzandosi, con una grande applicazione d�intelligenza e con maggior
esperienza, di trovare il mezzo per poter stampare i libri greci, cosa
difficile a causa della composizione cos� varia e numerosa delle lettere
impiegate nel greco e dell�attenzione tutta particolare che occorreva apportare
ai caratteri con gli accenti�.
Questa
esposizione, scrive Firmin-Didot, manca di precisione, ma conferma il senso di
dover dare il destro a Demetrio il
Cretese, di cui � fatta menzione nell�edizione di Omero di Firenze del 1488.
Verso
il 1489 � cos� che a Milano erano apparsi, senza l�indicazione dell�imprimatur, Esopo e Teocrito e, nel 1481
un Salterio greco, pubblicato a cura
di Jean Craston di Piacenza. Nel 1486, due cretesi, Alessandro (di Candace) e
Laoniceno, pubblicarono il primo Salterio,
la seconda la �Batracomiachia� di
Omero. Nel 1493, Isocrate, preparato da Demetrio Calcondila, fu stampato da
Enrico Germano o l�Alemanno e Sebastiano di Pontremoli.
La
terza citt� d�Italia che aveva stampato libri greci, prima del debutto di Aldo,
era Vicenza: Leonardo Achates di Basilea aveva stampato il 18 luglio 1488, la Grammatica di Lascaris e successivamente
nel 1490 e 1491 le �Erotemata� di
Crisolora, stampate per la prima volta a Venezia nel 1484. �
E� a
Firenze che nel 1488 i due fratelli Bernanrd e Nerius Tana�s, figli di Nerilius, �aveva presentato la novit� della prima
edizione di Omero, dedicata a Leone X; nella prefazione latina dedicata a
Pietro de� Medici, Bernardus Nerilius diceva che la rarit� dei testi greci gli
imponeva di intraprendere, prima di ogni altra opera, la stampa di Omero; che
sia lui, sia il fratello Nerius Tana�s,
l�avevano fatta a loro gusto con l�aiuto di Giovanni Acciaiuoli e con l�esperienza
(per la parte tipografica), di Demetrio il Cretese e� per la parte letteraria, dell�atemiese
Calcondila, di cui Nerilio si dichiarava discepolo.
La
prefaziome greca di Demtrio Calcondila, indirizzaata ai lettori, indicava
coloro che vevano contribuito all�esecuzione dell�opera, innanzi� citati, omettendo di parlare della sua
collaborazione. Egli, riferendosi a Demetrio il Cretese, lo indica con
l�epiteto di �milanese� che si spiega
con il desiderio di designare i suoi meriti artistici nell�esecuzione del primo
libro greco, la Grammatica di
Lascaris (del 1476) eseguita a Milano che, con la comparazione dell�Omero di
Firenze, avevano ambedue la stessa identit� dei caratteri.
E�
spiacevole, scrive Firmin-Didot, non
avere dei dettagli sulla parte tipografica
�attribuita a Demetrio il Cretese e allo
stesso modo a quella attribuita a Zacharias Calliergi il Cretese e altri
incisori e fonditori dei caratteri dell� �Etumologik�n
mega� da lui impresso a Venezia nel 1499, dove tutti i dettagli concernono
i punteruoli, le matrici, e la fonte del carattere, descritti in versi
greci� da Masuro (*).
E� cos� che
a Firenze, Lorenzo Francesco de Alopa aveva stampato nel 1494 �Antologia di Planude, in lettere
capitali greche, la cui forma imita quella delle iscrizioni lapidarie e cos�
altri quattro volumi pubblicati posteriormente con gli stessi caratteri
lapidari: Callimaco, Gnom� monastic�, Euripide e Apollonio
di Rodi.
Per ci� che
concerne Venezia, il primo libro stampato � l�edizione originale della
grammatica di Crisolora �Erotemata�
(Domande), in greco e latino: Impressum
Venetis per Peregrinum boniniense MCCCCLXXXIIII,
die
quinta febrarii (calendari
veneziano) corrispondente a 5 febbario 1485, di dieci anni anteriori alla data
di apparizione del primo libro stampato da Aldo, durnte i quali non si trova nessun
libro stampato a Venezia; i caratteri di questo testo sono di forma arcaica e
il libro � senza legatura e non vi � alcuna somiglianza con la bellezza e la
ricchezza dei testi di Aldo.
I testi
stmpati nel 1495 sono circa una diecina per tutta l�Italia; due grammatiche,
due salterii. Esopo, Teocrito, Omero e un oratore, Isocrate: ecco tutta
l�attivit� degli stampatori greci, anteriori ad Aldo.
�
*)
Giovanni Musurus, era uno studioso greco che aveva trovato rifugio nel palazzo
del principe di Carpi; non se ne conosce la data ma era di poco anteriore allo
stabilimento della stamperia di Aldo, col quale collaborer� per la stampa dei
testi greci. Da non confondere con Marco Masuro o Musurus di Creta, che aveva
le stesse mansioni ed era dello stesso livello culturale del precedente; membro
dell�Accademia fondata da Aldo e insegnante di belle lettere a Padova ed era cognato� di Giovanni Gregoropulos (designato come Giovanni di Candia).
FINE
PARTE PRIMA �